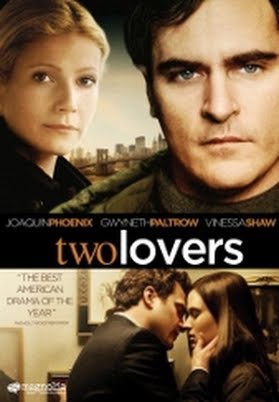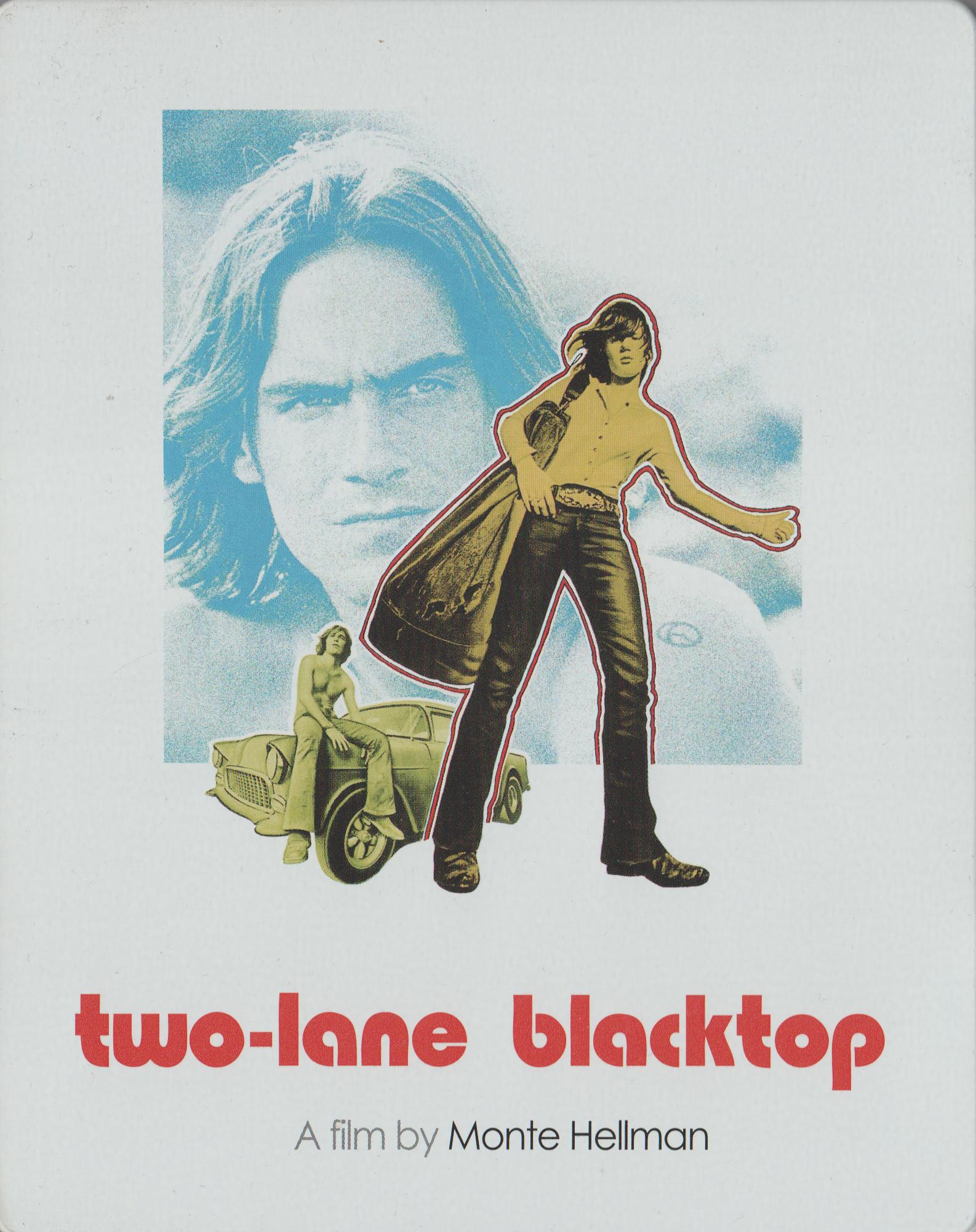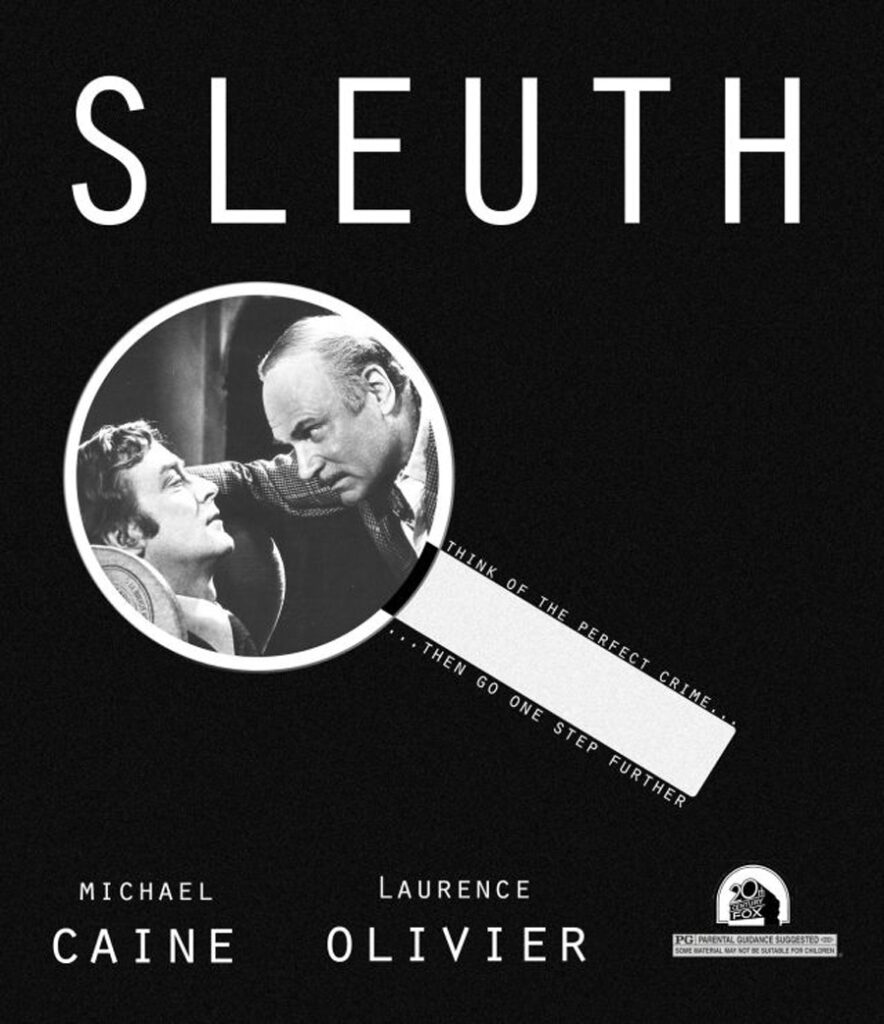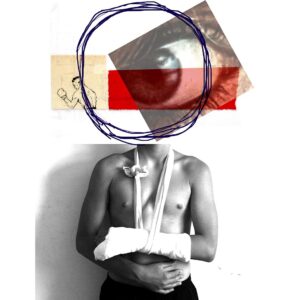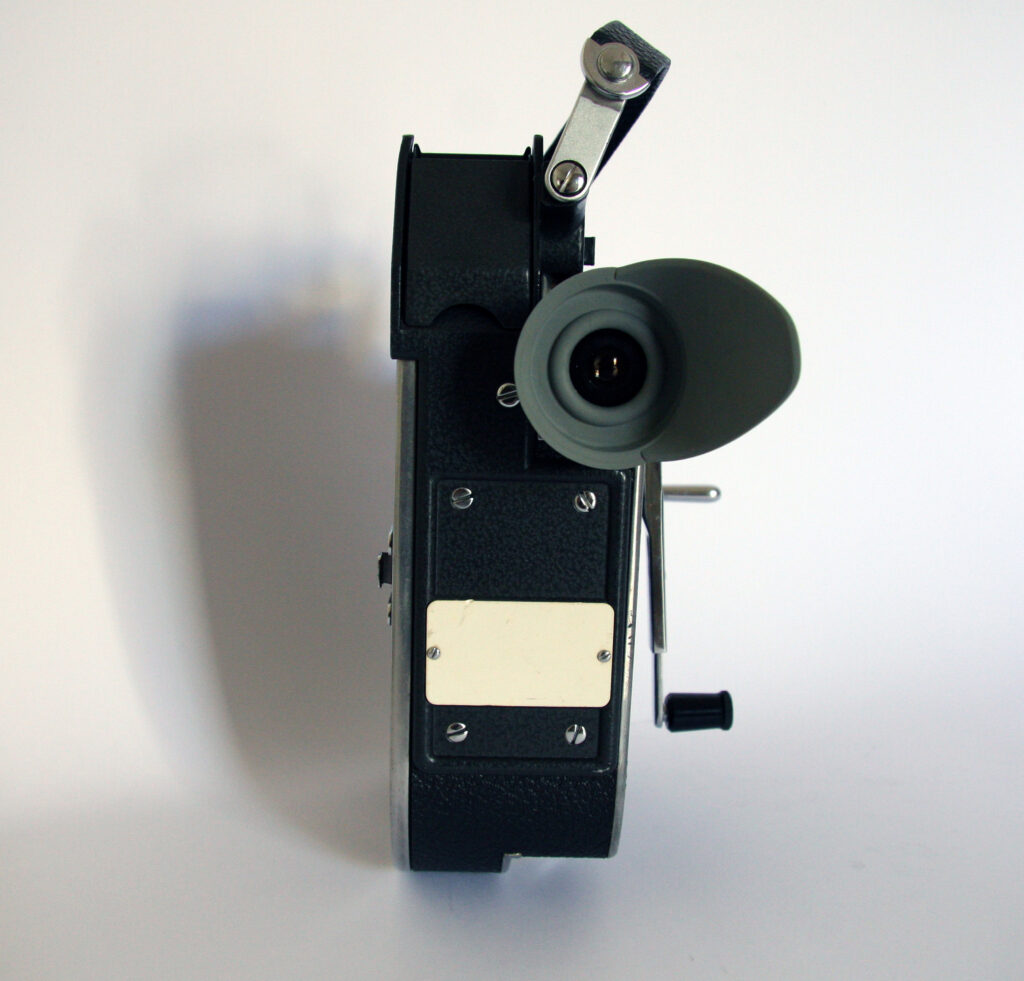UN EDITORIALE
Ecco un nuovo spazio mentale per chi ama il Cinema, i film ma soprattutto le idee, pensieri ed azioni che lo Spettacolo e la famigerata “macchina dei sogni” tende sempre più ad omologare. Il titolo di questo blog si deve alla scoperta della sorprendente varietà di rettangoli neri che è possibile trovare su Google alla ricerca “rettangolo nero”. La redazione di questa rubrica è formata da Sebastiano Pennisi, Livio Marchese, Alessandro Finocchiaro, Enrico Mapuche Lanza ed Alessandro Aiello ma attendiamo fiduciosamente che alcune amiche si decidano.
Stiamo sperimentando uno spazio mentale dedicato ad un’idea diversa, anti-autoritaria ed anti-accademica di critica all’interno della quale si alternano film recenti e meno recenti, visti o rivisti, che continuano però a cambiare sotto i nostri sguardi.
L’approccio non è “da gruppo”, le recensioni non sono firmate perché appartengono comunque ad un’area della quale condividiamo i princìpi generali, sono come i “rintocchi dal profondo” di cui tanto tempo fa ha parlato Herzog. Il fatto è che il cinema del passato (scoperto o rivisto) continua a riservare tante sorprese, con una potenza e lucidità forse mai più eguagliata, questo non rende tuttavia quello de “L’Immagine Mancante” un approccio nostalgico. Le immagini che arredano il blog sono “elettrografie” realizzate da nostro fratello Zoltan Fazekas.
INDICE:
TRE DONNE
THE EXPERIMENT
TWO LOVERS
STRADA A DOPPIA CORSIA
VISITORS
L’ANNO SCORSO A MARIENBAD
L’ULTIMA ONDA
BILLY IL BUGIARDO
LA LEGGENDA DI KASPAR HAUSER
U-TURN
A SANGUE FREDDO
LA CASA DEL PECCATO MORTALE
IL CLUB
CANI ARRABBIATI
GLI INSOSPETTABILI
COSMOPOLIS
NETFLIX E DONALD TRUMP
NOTTURNO
MALIZIA
GLI INVASATI
BUG. LA PARANOIA E’ CONTAGIOSA
PARADISE BEACH
LA MARCIA SU ROMA
POLYESTER
Y TU MAMA’ TAMBIEN
LE MIE NOTTI SONO PIU’ BELLE DEI VOSTRI GIORNI
SESSOMATTO
L’INGORGO
COME SONO BUONI I BIANCHI
CENSORED VOICES
MODELS
PRIVILEGE
SAFARI
HARRY, HE’S HERE TO HELP
MAMMUTH
UNA LUCERTOLA CON PELLE DI DONNA
YOUNG ADAM
DOGVILLE
AMORES PERROS
FAVOLACCE
BATTLE ROYALE
DER BUSENDFREUNDE
SIGNORE E SIGNORI
L’ULTIMO TRENO DELLA NOTTE
NIENTE DA NASCONDERE
BENNY’S VIDEO
UP!
WHERE TO INVADE NEXT
TEMPORADA DE PATOS
SUICIDE CLUB
CLUB SANDWICH
MALA NOCHE
NOI E L’AMORE: COMPORTAMENTO SESSUALE VARIANTE
LILITH LA DEA DELL’AMORE
SCEMI DI GUERRA
FUOCOAMMARE
CHIAMAMI COL TUO NOME
L’UOMO CHE FUGGI’ DAL FUTURO
AGUIRRE
REQUIEM FOR A DREAM
DONNE AMAZZONI SULLA LUNA
LA SOUFRIERE
- Tre Donne, di Robert Altman, 1977
La recensione che segue è stata scritta dall’amico Fiabo, che ha elaborato tutto quanto mentre andava in bicicletta, tutto direttamente in lingua inglese.
- The Experiment, di Oliver Hirschbiegel, 2001
Nel 1971 lo psicologo Philip Zimbardo condusse all’interno della prigione di Stanford (California) un esperimento sicuramente azzardato e ma illuminante, che costituisce tuttora la migliore letteratura della Psicologia Sociale sugli effetti collaterali di norme, ruoli, autorità, obbedienza e sulla capacità di contesti e situazioni estreme nel manipolare profondamente la percezione, l’etica ed il comportamento dell’uomo..
Il complesso dispositivo della finta prigione diventa subito il protagonista principale (che assume vita propria) con i suoi personaggi: finto direttore, finte guardie carcerarie e finti detenuti. L’esperimento di Stanford (ed anche quello di Stanley Milgram) riveleranno come la classica dicotomia bene-male e buoni-cattivi è in realtà solo una banale e consolatoria semplificazione.
Col passare del tempo, l’esperimento si è rivelato un’efficace illustrazione del ruolo potenzialmente tossico dei cattivi sistemi e delle cattive situazioni nell’indurre brave persone a comportarsi in modi patologici, estranei alla loro natura.La frontiera tra Bene e Male, un tempo ritenuta stagna, si è invece dimostrata piuttosto permeabile. (P.Zimbardo)
 still dalle riprese video realizzate nella Prigione di Stanford (1971)
still dalle riprese video realizzate nella Prigione di Stanford (1971)
Ciò che successe allora a Palo Alto è uno spunto molto interessante, che ha generato finora 3 adattamenti cinematografici. Si pongono agli estremi questo asciutto film tedesco ed uno “spettacoloso” remake hollywoodiano (Paul Scheuring, 2010) con attori famosi (Adrian Brody e Forest Witaker, specialisti di ruoli drammatici). Nel 2015 esce anche “The Stanford Prison Experiment” di Kyle Patrick Alvarez, del quale leggerete presto in questo blog.
Nel potentissimo libro “The Lucifer Effect. How Good People Turn Evil” (2007, 710 pagine nell’edizione italiana, edito da R.Cortina) il Professor Zimbardo racconta per la prima volta la storia vera, intrecciando con uno stile asciutto e visivo lo sbobinamento delle asettiche documentazioni video effettuate di nascosto (cercatele su Youtube), i report scritti dalle cavie stesse e naturalmente le proprie puntali notazioni filosofiche.
Il fatto è che dopo aver letto il suddetto libro anche il migliore di questi film risulta perdente in partenza, un pallido tentativo di drammatizzare la cosiddetta Verità, o ciò che successe nel corso di quei 6 interminabili giorni.
“The Experiment” (“Cercasi cavie umane” è il furbo sottotitolo dell’edizione italiana) di Oliver Hirschbiegel è un film onesto e schematico basato sul libro di Mario Giordano (“The Experiment – Black Box”) che si ispira pure lui all’esperimento. La sceneggiatura si distacca dalla cronaca originaria: il film è ambientato infatti in Germania e propone una seconda dimensione inserendo la storia d’amore tra il personaggio principale (il detenuto 77) e la giovane Dora (una dimensione parallela sempre costante), le soggettive in bassa definizione realizzate segretamente sempre da 77 con i suoi occhiali-telecamera, ed altre soluzioni narrative tipiche di un film d’azione ansiogeno con buoni e cattivi, massacro finale e finalmente epilogo romantico.
Le fatali oscillazioni di ogni singolo carattere umano all’interno di questo claustrofobico atto di Teatro totale, la crescente contaminazione tra realtà e finzione li troverete nella scrittura di Zimbardo. E’ soltanto lì il vero, irrappresentabile inferno dell’esperimento della prigione di Stanford.
In futuro troverete quì stesso raccontati “L’Onda” (Die Welle, D.Gansel, 2008) che rielabora un altro esperimento americano, “La terza onda” (1967) in cui un professore americano dimostra ai propri strumenti in che modo a partire da un piccolo nucleo è possibile progettare uno stato totalitario.
Rimanendo in tema “Experimenter” (2015) che narra dello psicologo Stanley Milgram e di un ennesimo esperimento su cavie umane.
- Two lovers, di James Gray, 2008
Un dramma sentimentale basato su un triangolo amoroso non è certo una novità, eppure la tormentata storia di Leonard (il carismatico J.Phoenix), Sandra e Michelle (G.Paltrow) ha ottime qualità narrative ed un bel finale (positivo ma non americano nel senso che potevamo temere) ed invita inoltre ad illuminanti considerazioni sull’amare maschile e femminile (quest’ultimo senza dubbio vincente dal punto di vista morale).
Il tema principale di “Two lovers” è la sovrapposizione tra una storia d’amore forse troppo pulita e lineare ed un’attrazione fatale, che oltre a soddisfare gli istinti di Leonard (tormentato, fragile ed elemento principale di disordine) significa anche sabotare una prospettiva familiare/sociale confortante ed oppressiva. Caos e fato si intrecciano all’interno di un affresco delicato e pieno di dettagli, sempre però distante dalla retorica del film commerciale e via via sempre più carico di dinamiche thrilling ansiogene. Alla fine sarà il caso a ricomporre tutto ed a decidere per Leonard (ed assieme a lui) la cosa giusta da fare, lasciando immaginare a noi che guardiamo, il peso del suo senso di colpa. Interessante la figura della madre (Isabella Rossellini) invadente ed amorevole nelle proporzioni giuste, eccessivo il doppiaggio iper-esistenzialista di J.Phoenix.
- Strada a doppia corsia, di Monte Hellman, 1971
A 30 minuti dall’inizio mi sentivo ancora intrappolato in un b-movie interlocutorio, che però si sviluppava attraverso una regia sapiente e senza fronzoli. Poi è successo che tutto ciò che era in prima piano si trasformava in sfondo e quindi le corse in auto, i motori, le sfide a pagamento, l’autostop e gli incontri fortuiti diventano astratti e quasi metafisici. Quella di “Two Lane Blacktop“ è un America diversa da quella inquietante (ed attuale) di “Easy Rider”, l’inquietudine giovanile è venata di autodistruzione ma viene raccontata senza la retorica di “Gioventù Bruciata”. Nell’ultima scena manca il sonoro e questo trucchetto ci prepara ad un magnifico, inatteso finale. Il film è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.
- Visitors, di Godfrey Reggio, 2013
Dopo aver realizzato la sua nota trilogia, G.Reggio approfondisce in questo film le sue teorie sullo sguardo. Esaurito il sincero messaggio ecologista della trilogia “Chi e cosa può essere considerato ‘visitatore’ quando ci guardiamo intorno su questo pianeta?” è il motivo di “Visitors”
Inizia con lo sguardo enigmatico della gorilla Triska (filmata in uno zoo di New York), cui seguono tanti altri primi piani di uomini e donne (inespressivi e poi invece tutti con una espressione) a camera fissa, poi ancora gruppi di volti ad eventi pubblici, palazzi e nuvole in time-lapse, luoghi naturali, luoghi antropizzati ormai morti. Le immagini sono spesso rallentate (abbiamo più tempo per guardarle e per pensarle, anche); però è quando abbiamo meno elementi (i volti) che ci sembra di vedere qualcos’altro rispetto a ciò che viene mostrato. Poi c’è il mistero dello “sguardo in camera” (il cinema che guarda noi mentre siamo al cinema) ma non è questo il luogo né il momento. “Visitors” avrà soddisfatto le esigenze formaliste di G.Reggio (impeccabile bianconero e grande perfezione formale, maggiore che nei 3 film a colori della trilogia) ma è un’occasione mancata per via delle musiche sovratono di Philip Glass che rovinano la circolarità della struttura visiva e soprattutto cercano presuntuosamente di riempire un vuoto –nella consueta retorica orchestrale minimalista con la quale il celebre compositore ci affligge da decenni- togliendo profondità alle immagini ed immaginazione a noi che le guardiamo. Proviamo a vederlo senza audio, qualcosa succederà.
Ecco infine come l’industria “vende” il film in questione:
“Famoso per la trilogia Koyaanisquatsi/Powaqqatsi/Nagoyqatsi, il regista Gosfrey Reggio ha creato con “Visitors” un altro squisito poema visivo” (mymovies.it)
- L’anno scorso a Marienbad, di Alain Resnais,1960
Probabilmente Alain Resnais ha rivolto principalmente a cinefili e colleghi cineasti questo perverso esercizio di stile in bianconero. Sperimentale e pretenzioso, sicuramente datato, “L’anno scorso a Marienbad” premiato con il Leone D’oro al Festival di Venezia (1961) e probabilmente detestato dallo spettatore medio sembra mostrare luoghi, parole, azioni e personaggi con lo scopo di rimuovere il racconto stesso, in una inutilità glaciale che può ricordare le scene descritte da Thomas Bernhard. In un tempo lineare continuamente distrutto non succede molto: soltanto le strategie seduttive di X (Giorgio Albertazzi) rivolte ad A (Delphine Seyrig) che si susseguono senza soluzione alcuna nei bellissimi interni/esterni di un albergo di lusso, attraverso un gioco claustrofobico di ripetizioni, rimandi, flashback esasperati dal montaggio creativo (sicuramente azzardato per quell’epoca).
- L’ultima onda, di Peter Weir, 1977
Non a caso questo non è uno dei film più di successo di Peter Weir, e mi ha colpito per la qualità della sua visionarietà. Un tranquillo avvocato di Sidney deve difendere un aborigeno da un’accusa di omicidio e si trova sempre più risucchiato all’interno di una dimensione magica, fino a scoprire che egli stesso è parte attiva di una profezia che anticipa la distruzione del mondo. Colpisce la maniera con la quale il regista riesce a trattare il tema ecologista (che a quell’epoca non era forse così attuale) e la condizione aborigena in un thrilling piuttosto avvincente ma al tempo stesso lontano dalla retorica di Hollywood.
La catastrofe ambientale cova anche in “Mosquito Coast” (1986) nel quale però la presenza di Harrison Ford, in fuga dall’America civilizzata con la sua famiglia ispira un film d’avventura dalle dinamiche meno interessanti e più prevedibili, non fosse per la presenza del personaggio del predicatore cristiano e di un conflitto che culminerà con la morte dello stesso H.Ford; in una delle scene madri una predica videoregistrata per un gruppo di indigeni, all’interno di una chiesetta di legno. Che a sua volta rimanda ad un problema attuale: l’evangelizzazione forzata nei confronti dei popoli nativi del Sud America.
- Billy il bugiardo, di John Schlesinger, 1963
L’inquietante inadeguatezza del giovane Billy, lavoratore dipendente, figlio e fidanzato, ha una ragione precisa: egli vive anche nel mondo di Ambrosia, regno immaginario nel quale ha finalmente un ruolo, che nella claustrofobica vita britannica subisce fin dalla nascita. Billy non vorrebbe mai essere lì ed in quel momento, perseguendo il sabotaggio di ogni momento sociale che lo riguarda: crea continuamente nuovi problemi lasciandoli accumulare senza risolverli, è una prospettiva affascinante ma distante dal nichilismo classico. Non avevo mai visto questo ispiratissimo film in bianconero girato negli anni 60 in stile nouvelle vague, solo dopo che è terminato ho realizzato come fosse magicamente triste ed esilarante, luminoso e drammatico, acido fino ad un grande (sconsolante) finale, che non lascia scampo neppure a noi che guardiamo e che abbiamo sperato per lui. Anche questo titolo è disponibile gratuitamente sulla piattaforma www.hd4me.net, che ci permette di scoprire tanto importante cinema del passato.
- La Leggenda di Kaspar Hauser, di Davide Manuli, 2012
Questo film sembra generato dalle aspettative stesse dello spettatore. Sarebbe il titolo ideale da proiettare ad un convegno medico sull’afasia (e altri disturbi del linguaggio) ed al tempo stesso un pezzo d’arte contemporanea (in bianconero) da osservare sicuramente non stando seduti, ma mentre si cammina e si fanno altre cose. “La leggenda di Kaspar Hauser” ha comunque il merito di mettere in crisi le nozioni di sintassi e struttura cinematografica: E’ orizzontale ed artistico, presuntuoso e pretestuoso ed incapace di complessità narrativa -lo dichiara apertamente- un anti-film, ma non in maniera veramente radicale. Kaspar Hauser (interpretato da una donna con pochissimo seno, sempre a torso nudo, ) arriva dal mare ed ha un progetto importante, e le similitudini col Kaspar Hauser di Herzog finiscono qui.
La storia-non storia procede attraverso una serie di capitoli filmati a camera fissa, ognuno col proprio titolo, nei quali 2 o 3 personaggi compiono un’azione teatrale interlocutoria; sembrano obbligati ad esprimersi con dialoghi e monologhi, con risultati quasi sempre imbarazzanti (come i preamboli dei film porno) tanto che i momenti più liberi e spontanei mi sono sembrati quando i corpi maschili e femminili si muovono sullo sfondo di musica tecno, con un curioso effetto antico-contemporaneo. “La leggenda di Kaspar Hauser” non vive di necessità creative particolari: la bellezza dei luoghi e delle donne sembrano essere lo Spettacolo, ma si tratta di un anti-film e allora, forse, va bene così. All’inizio del film un cartello avvisa che la Regione Sardegna considera il film opera d’interesse artistico.
- U-Turn di Oliver Stone, 1997
E’ un film molto ispirato e tuttosommato divertente, contrassegnato da un’estetica e grammatica video che iniziava maliziosamente ad introdursi nel Cinema mainstream sul finire degli anni 90. Oliver Stone aveva già sperimentato questa contaminazione nel 1994 con il superficiale ed iper-formale “Assassini Nati”; Nel caso di “U Turn”invece la dimensione estetica mi sembra funzionale alla narrazione, proponendo anzi stimoli interessanti alla costruzione del racconto.
“Un giocatore d’azzardo, inseguito dai creditori, e una femmina fredda e bollente, tormentata dal potente marito, vogliono solo andarsene da Superior. E per farlo sono pronti anche ad uccidere”. (note del dvd del film)
La storia sarebbe quella tipica del film di genere ma il film è basato su un romanzo di per sé claustrofobico (“Come Cani Randagi” di John Ridley) e sulla performance estrema degli attori e Oliver Stone sposta la narrazione su un piano ironico e visionario, in cui il montaggio ed insert rapidi generano continue suggestioni attraverso la linea presente-passato-futuro.
Superior (Arizona) è un ambiente nel quale la sottile psicopatia di tutti quelli che Bobby Norton/Sean Penn troverà fatalmente sul suo cammino (l’ambigua Grace/Jennifer Lopez ma anche il satanico Jake/Nick Nolte ed il folle meccanico che tiene in ostaggio la sua automobile) si misura continuamente con una sensazione molto forte di immobilità, controllo sociale, desiderio carnale, caldo asfissiante e spazi infiniti. Nella scena di chiusura il tableau vivant aereo con i 4 personaggi morti o quasi-morti suggerisce che in una storia del genere non vi sarebbe comunque potuto essere un lieto fine. Anche questo titolo su www.hd4me.net
- A Sangue freddo/In cold blood
“In cold blood” rappresenta una buona occasione per immergersi nei misteri del linguaggio, facendo spostare di volta in volta tra cronaca, letteratura e Cinema fatti e personaggi. Una sera del Novembre 1959, nella sonnolenta cittadina di Holcomb (Kansas) i 4 componenti della famiglia Clutter vengono inspiegabilmente massacrati in casa. Il giornalista Truman Capote ricostruisce fatti e contesti sociali attraverso una laboriosa (e spesso prolissa) operazione di pura archeologia (non a caso il testo fu pubblicato a puntate sul New Yorker).
Mescolando scrittura giornalistica e invenzione letteraria Capote inventa la “non fiction novel”, “In Cold Blood” (1966) coi suoi 6 anni di gestazione ha un grande successo e resterà inesorabilmente incollato a Truman Capote per tutta la vita, come una maledizione.
1967, Richard Brooks realizza “ In Cold Blood”, un avvincente e claustrofobico film che racconta in scala 1:1 ed in bianco e nero il fatto di sangue, dalla preparazione del piano all’impiccagione dei due assassini.
Tuttavia, è proprio dopo aver guardato il film che si apprezzano le qualità cinematografiche (con tanto di montaggi paralleli) del “romanzo-documento” di Capote. Nel 2005 viene raccontata un’altra storia: in “Truman Capote in cold blood” Bennett Miller decide di inserire in scena l’effeminato dandy Truman Capote (impersonato da un debordante Philip Seymour Hoffman). Il giornalista-scrittore è inesorabilmente attratto dal caso Clutter e coinvolto nel procedimento giudiziario, tanto da riuscire a far riviare l’esecuzione per ben 5 anni.
Pur essendo i classici perdenti Percy Smith e Richard Hickock non sono affatto due personaggi banali, hanno sfiorato il delitto perfetto perchè non conoscevano le vittime ed avevano percorso in automobile oltre 1000 chilometri per compiere un massacro senza movente.
“Truman Capote in cold blood” è un film a colori secco ed essenziale cheaddentrandosi nella psiche dello scrittore riesce magnificamente ad accendere l’immaginazione di chi lo guarda. Le scene del delitto vengono mostrate brevemente all’inizio del film, come fossero dei reperti, a
riprova del fatto che è stata la fatalità a guidare gli eventi: i Clutter (che non nascondevano in casa nessuna cassaforte e fruttarono ai 2 assassini solo 40 dollari) non erano colpevoli di nulla ma per una serie di ragioni inconscie erano dei predestinati e dovevano pagare per tutti.
I 4 spari nella notte infliggono una profonda ferita in una America tranquilla e perbene (i cittadini non si chiudevano a chiave in casa di notte) per la quale il bene e il male occupano i loro posti rassicuranti, una nazione dominata dai valori di famiglia, lavoro e religione ma piuttosto distante dall’America paranoica di oggi. Nel 2006 ecco un terzo film (che non ho visto): “Infamous – Una pessima reputazione” di Douglas McGrath, altra riscrittura e drammatizzazione del massacro che non credo possa aver raggiunto molto ai due ottimi film già realizzati. Un film mainstream con attori piuttosto famosi, incentrato sull’affinità omoerotica di Truman Capote e Percy Smith.
- LA CASA DEL PECCATO MORTALE di P.Walker, 1976
Questo thrilling gotico a basso budget, in pieno e fiero stile anni ‘70 (uscito in inghilterra col titolo “The Confessional Murders”) inizia con la scena di una giovane donna che si suicida spinta da ossessioni religiose. Il diabolico Padre Meldrum, represso sessualmente e tormentato da un passato tutt’altro che risolto incontra nel confessionale la bella Jenny. Attraverso il desiderio per la donna scatena la propria furia punitiva nei confronti di ogni peccatrice e peccatore, eliminando inesorabilmente chi cerca di ostacolarlo (compresa l’anziana e disabile madre). “La casa del peccato mortale” racconta in fondo i meccanismi del senso di colpa e dell’espiazione ed il potere coercitivo della religione, che vediamo anzi intrecciato con quello della medicina (i crimini silenziosi di Big Pharma erano già in atto, più che altro negli Stati Uniti). Ciò che personalmente conservo del film è come la chimica diventi un sottile strumento di controllo attraverso la promessa di benessere, che sarebbe in un certo senso il lavoro della religione. Il film ha un buon ritmo narrativo e ambientazioni claustrofobiche, nonostante soluzioni narrative a volte francamente improbabili, che del resto ci aspettiamo dal cinema di genere. Un buon film di Natale, volendo. Anche questo scaricabile legalmente da www.hd4me.net
- IL CLUB di Pablo Larrain, 2015
“Il club” racconta le vicende umane che ruotano attorno ad una particolare casa di penitenza sulla costa cilena. I 5 residenti sono ex sacerdoti che hanno avuto problemi con le rispettive comunità (si va dalla pedofilia al rapimento e riassegnazione di bambini nativi) e che hanno bisogno di ritrovare un equilibrio attraverso disciplina e preghiera. Allevano ed allenano un levriero col quale partecipano con profitto alle corse dei cani e questo alimenterà pian piano crescenti tensioni con l’esterno. Le giornate di reclusione volontaria vengono gestite da una sorvegliante (che resta il personaggio più inafferrabile ed inquietante del film) fin quando l’arrivo di un altro ospite, Padre Mati, non romperà questo equilibrio: Il sacerdote viene presto perseguitato da un giovane che aveva subìto da lui stesso abusi sessuali, quindi (accusato dagli altri) si suicida utilizzando una pistola. Il film si avvia rapidamente verso un climax inarrestabile, arriva da Santiago un giovane emissario del Vaticano per svolgere indagini ed interrogatori. Nei dialoghi con ciascuno di loro è custodito il grande valore del film: fede, contrizione, peccato, la scissione tra anima e corpo, il senso di colpa prendono corpo in un pensiero complesso e doloroso. Ognuno di loro è essere positivo/negativo, difende strenuamente i propri peccati e le proprie debolezze; mentre guardiamo ed ascoltiamo questi primi piani veniamo messi di fronte alla rappresentazione di una inquietante continuità (tra l’altro argomentata in maniera non retorica) tra le ragioni della fede e quelle del desiderio (principalmente omosessuale). Il gruppo, sentendosi minacciato, è capace di atti di cattiveria per sopravvivere: avvelenano un cane avversario, sacrificano il loro stesso levriero per fare in modo che il giovane venga poi accusato e linciato dalla folla. L’esecutore infine ripartirà, con la certezza che ogni ferita sarà rimasta aperta e sanguinante. Il film alterna alcuni momenti di estrema cura estetica a molte altre immagini che riescono ad essere efficacissime nella loro ordinarietà.
- CANI ARRABBIATI di Mario Bava, 1975
“Cani arrabbiati” è un thriller maledetto di alto livello che ci restituisce con una certa personalità e complessità la cronaca nera italiana di quegli anni 70. Atipico nella produzione di Mario Bava (che si dedicò all’horror) e tratto da L’uomo e il bambino (giallo della collana Mondadori) “Cani arrabbiati” fu un film maledetto anche per via delle problematiche economiche e legali, sequestrato in fase di montaggio per bancarotta e tenuto da parte, non poté essere visto completato dal regista perché morì prima. Mario Bava (citato non solo dal solito Tarantino ma anche da Tim Burton, ma sono convinto che questo film in particolare piacerebbe a Polanski) ha concepito un film tanto estremo quanto accurato nei dettagli, drammaturgicamente ineccepibile tra scrittura e linguaggio visivo, tanto da costituire un modello inarrivabile del genere polizziotesco. Notevoli la caratterizzazione psicologica dei personaggi (compressa tra umanità e disumanità) ed il ritmo visivo imposto allo spettatore. Il corpo è il vero protagonista di “Cani arrabbiati” tra sudore, movimento e ferite, naturalmente quello femminile è centrale ma a dispetto di un erotismo latente non vi sono scene di stupro. Il viaggio claustrofobico dei 3 rapinatori in automobile (il capo/regista del piano e 2 giovani psicopatici) lungo autostrade e stradine di campagna è un percorso infernale, disseminato di situazioni disturbanti. Vi è perfino un finale a sorpresa, e nessuna speranza.
- GLI INSOSPETTABILI di J.Mankiewicz, 1972
E’ l’ultimo film di Mankiewicz, tratto dal lavoro teatrale di Anthony Schaffer.
Commedia (drammatica), mi sembra un’eccellente metafora della guerra contemporanea, in cui la vittoria militare sottintende senza alcun mistero distruzione e sfaceli sociali e civili. L’aristocratico e inumano scrittore di libri gialli Andrew Wyke (Laurence Olivier, al massimo della forma attoriale) invita nella propria villa, isolata nella campagna inglese, Milo Tindle (Michael Caine, anche lui eccellente) per discutere e regolare la transizione sentimentale e matrimoniale della sua ex moglie, che è adesso innamorata dell’altro. Wyke propone al rivale un allettante e raffinata operazione criminosa vantaggiosa per tutti (il furto di gioielli assicurati appartenenti a lui stesso) ma il suo unico scopo è quello di umiliare e annientare il rivale, terrorizzandolo con una diversione del piano. Attraverso vicende claustrofobiche (ma divertenti) non riuscirà nel suo intento e non potendo essere vincitore, non gli resterà che ucciderlo veramente. Il duello tra i 2 grandi attori (unici personaggi) è diabolico, estenuante (sempre di alto livello drammaturgico) e senza esclusione di colpi, sullo sfondo di considerazioni acide sul conflitto di classe e sulle aspirazioni sociali dell’uomo.
- COSMOPOLIS di D.Cronenberg, 2012
Eccellente film dal romanzo omonimo di Don De Lillo, anche qui Cronenberg ripropone un inesorabile conflitto corpo/mente. Il giovane miliardario Erick Packer compie un lungo tragitto nella propria limousine per raggiungere il suo barbiere, nell’altra parte di New York. E’ un viaggio neanche troppo metaforico (forse omerico) attraverso il fallimento ed il disfacimento, dal momento che la città è sconvolta da tumulti sociali -visibili e non visibili- e che l’intento di Packer, sempre più inespressivo e filosofico, è in realtà quello di arrivare in fretta ad una resa di conti con sé stesso. La limousine/macchina rappresenta una dimensione concreta/astratta ipnotica, all’interno della quale Packer conclude riunioni di lavoro, riceve collaboratori e la giovane e altrettanto facoltosa moglie (complice di un matrimonio fallimentare) fa sesso con la sua manager, riceve il suo medico privato per una visita alla prostata, osserva stancamente la realtà sugli schermi integrati. Con lo scorrere di questo ambiguo e affascinante tempo lineare Packer si concede alcune brevi fughe esterne, poi assistendo ad un tracollo finanziario sempre più vicino uccide senza motivo il responsabile della (sua) sicurezza, si sottopone all’aggiustamento del taglio dei capelli (senza però completarlo) consegna la limousine al parcheggio (non curandosi assolutamente dei danni esteriori sofferti dalla carrozzeria) e si dirige verso il conflitto finale con l’uomo che da tempo lo minaccia e che desidera ucciderlo per dare finalmente un senso a qualcosa. Eccellente la colonna sonora, narcotica quanto il film stesso.
- Netflix e le Presidenziali statunitensi
Ci sono almeno due prodotti su Netflix che entrano nella narrazione della compagna elettorale delle Presidenziali USA. E parlo di prodotti, proprio perché la bancarella Netflix li promuove come oggetti di consumo scontati (si intenda l’aggettivo «scontato» qui nelle due accezioni d’uso della variegata lingua italiana).
When they see us è una miniserie uscita su Netflix Italia nel 2020. Tratta da una storia vera, per quello che può significare sul grande o sul piccolo schermo, la serie racconta di cinque ragazzini, di età compresa tra 14 e 16 anni, giudicati come adulti in tribunale per un reato mai commesso. I ragazzini, neri o ispanici, stavano rumoreggiando (wilding) in Central Park, dove era stato poi trovato il corpo di una donna bianca, in coma, dopo uno stupro e un brutale pestaggio. Gli organi inquirenti costruiscono una narrazione perfetta e stringente, utilizzano le famiglie stesse dei giovani imputati – povere e socialmente vulnerabili – per inchiodarli a un crimine odioso e morbosamente attrattivo per l’opinione pubblica, come la violenza carnale.
In tempi di Black Lives Matter, la scelta del soggetto e l’impianto retorico dell’intera serie, risultano decisamente orientati a prendere posizione all’interno della campagna elettorale contro il secondo mandato di Donald Trump. Ma a voler fugare qualsiasi dubbio, c’è una sequenza con la madre di un giovane accusato che assiste attonita a una trasmissione televisiva, nella quale viene proposta un’intervista a Donal Trump (una registrazione del 1989, andata realmente in onda in televisione). Trump era intervenuto pesantemente durante il processo, con una campagna d’odio sui giornali, pagata di tasca sua, al fine di ripristinare nello stato di New York la pena di morte per chi si era macchiato di crimini aberranti e odiosi. Trump aveva speso migliaia di dollari per acquistare pagine pubblicitarie sui quotidiani e chiedere la condanna a morte di un quattordicenne, tre quindicenni e un sedicenne. La madre del ragazzino accusato scoppia in lacrime e un’amica, che guarda la tv insieme a lei, cerca di consolarla dicendole: «non preoccuparti, questo qui è uno che cerca il suo quarto d’ora di notorietà. Fra pochi mesi nessuno si ricorderà più di lui». Al momento, alcuni sondaggi riportano che ha recuperato lo svantaggio e rischia di essere eletto per un secondo mandato a Presidente degli Stati Uniti d’America, nonostante i 200.000 morti determinati da una gestione sconsiderata dell’emergenza Covid e nonostante il Paese sembri sempre di più sull’orlo di una guerra civile.
Jeffrey Epstein: filthy rich è una miniserie documentaria, che racconta l’ascesa misteriosa e la caduta fragorosa del miliardario pedofilo che dà il nome al progetto. Anche qui le fotografie e i video sembrano indugiare sulle amicizie altolocate del finanziere di Wall Street, con una speciale attenzione per i found-footage riguardanti Donald Trump. Tante volte avevano viaggiato insieme e si erano incontrati, tante volte avevano parlato di donne, perché entrambi si vantavano di essere dei “predatori” (sic). Ma proprio nel momento della rovina di Epstein, Trump aveva tenuto a precisare che avevano litigato e non si parlavano da 15 anni. Anche questo vigliacco rinnegare è nelle corde del personaggio, che spesso rimaneggia e modifica le narrazioni con ricordi inventati e bugie rivendicate con orgoglio.
Non sappiamo cosa succederà a novembre. Otto anni di Obama non hanno minimamente migliorato la situazione sociale statunitense, anzi ne hanno aggravato il livello di conflittualità, soprattutto nelle frange dei suprematisti bianchi e nel KKK. Trump ha utilizzato questo malcontento e lo ha monetizzato. Ora come allora, la Società dello Spettacolo hollywoodiana si è schierata in maniera netta a favore del Partito Democratico. È curioso come tutto questo non serva a niente se non al posizionamento strategico nello scacchiere politico americano. I campionati NBA, rinchiusi a Orlando in The Bubble, continuano a sbandierare posizioni e promuovere gadget. Le magliette nere con la scritta bianca «Black Lives Matter» sono diventate di moda. Ma le periferie delle città sono in fiamme e la polizia spara ad altezza d’uomo. I nomi delle vittime nere da celebrare e ricordare crescono di settimana in settimana. Sul bouquet di Netflix Italia fioriscono però i titoli, per ricordarci quanto sia sbagliato il razzismo. Sembrano lezioni di catechismo.
- Notturno di Gianfranco Rosi, 2020
Nell’intenzione di Rosi Notturno è un film di luce dai materiali oscuri della storia. L’Autore, dopo una generica didascalia che inquadra la condizione storica di alcuni paesi del Medio Oriente, organizza una serie di inquadrature studiatissime da National Geographic o Agenzia turistica attorno a quella che dovrebbe essere la questione affrontata: la vita nei territori di confine del Medio Oriente minacciati da un continuo stato di guerra. Fotografia e suono accuratissimi. Pochi dialoghi rimarcano la condizione di sofferenza di chi inerme subisce la violenza. Ci scorrono davanti agli occhi, sapientemente intrecciate nel montaggio, riprese perfettamente calibrate e spettacolari della vita quotidiana di gente comune, dei più fragili e dei più a rischio, e di paesaggi nelle zone di confine in prossimità o già teatro di guerra (si sentono gli spari in lontananza): le esercitazioni militari anche di soldatesse o di sentinelle ai turni di guardia in un tempo sospeso da “Deserto dei tartari”, il compianto delle madri in una prigione dove sono stati torturati i figli, le testimonianze in una scuola dell’infanzia balbettate da un bambino traumatizzato dalla visione delle atrocità commesse dall’Isis, la quotidiana fatica di minori o disagiati, costretti a cacciare o pescare in condizioni miserabili e precarie per la sopravvivenza delle famiglie composte di donne e bambini, la messinscena di una lamentazione sul destino della patria da parte degli ospiti di un ospedale psichiatrico, una madre ascolta i messaggi audio della figlia prigioniera di uomini di Daesh, altri prigionieri appartenenti all’ISIS vengono inquadrati in un assembramento bestiale nelle carceri militari; in sostanza la vita di chi subisce le conseguenze di una guerra voluta dai “cattivi”, che restano sullo sfondo o nei disegni dei bambini o nelle immagini della tv nel teatrino dell’ospedale o in un tablet guardato dalle donne di casa. Notturno è un film che racconta la guerra senza mostrare la guerra, mostra gli effetti della guerra sulle persone, mettendo, nelle pie intenzioni di Rosi, in primo piano l’umanità, ma è un’umanità che subisce, non interpellata, non invitata ad interrogarsi. Rosi afferma che i tre anni occorsigli per girare il film lo hanno cambiato profondamente, un’esperienza dal forte impatto emotivo e fisico. Noi gli crediamo, pure quando afferma che ha passato molto tempo con i suoi personaggi prima di filmare e che si è interrogato sulla legittimità di mostrare in viso i piccoli scolari. Il risultato della sua operazione resta, in ogni caso, fortemente compromesso dall’idea di partenza e dalla intenzionalità esplicitata e blindata di produrre ad ogni costo delle storie esemplari senza approfondirle a dovere e senza farsi contaminare da una realtà che alla fine gli resta incomprensibile ed estranea. Il suo ideale, anche estetico, prevale sulla realtà, la sua discrezione e freddezza dietro la macchina da presa ci sembra incline a un certo compiacimento per l’immagine perfetta, valida come monito per tutti, simbolo dell’ingiustizia e della crudeltà perpetrate sui più deboli da parte dei signori della guerra e dei padroni dei pozzi petroliferi sullo sfondo. Rosi utilizza le immagini come altri utilizzerebbero la voce fuori campo, con l’ambizione di poter raccontare e spiegare l’essenziale facendo luce con la sua telecamera. L’assunto aprioristico è che il grande cinema deve far parlare le immagini, ma l’impressione finale è quella di uno stucchevole narcisismo, di ambiguità morale e di inerzia intellettuale. L’Autore è come un dio passivamente adagiato a contemplare dell’esterno la tragedia della follia umana. È al di qua della tragedia, non si sporca le mani, non gli interessa indagare le questioni economiche, religiose e sociali e le cause degli orrori perché è già tutto chiaro: da un lato ci sono i cattivi e la loro logica aberrante, dall’altro le vittime. La visione delle cose ingenua e inumana di un ladro di belle immagini, uno sguardo nient’affatto empatico, più inteso alla composizione dell’inquadratura perfetta che all’ascolto sincero di chi non ha voce e sguardo perché anche quello gli è stato colonizzato. Emerge un palese disinteresse per la comprensione profonda di una realtà cosi problematica e, per molti versi sfuggente, come quella del Medio Oriente e per una resa documentaristica nutrita dalle contraddizioni e dai diversi punti di vista di chi vive anche le conseguenze dei conflitti esistenti. Evidentemente Rosi non ha lo spirito del documentarista, non scopre né indaga né svela realtà inedite e altre visioni dei fatti. Sembra a caccia di suggestioni utili ad alimentare il suo smodato amore per la bella immagine. Il suo “Notturno” aggiunge oscurità, e malgrado le sue intenzioni, non rischiara ragioni né accende emozioni. Ben più originale e più schietto l’approccio documentaristico di Stefano Savona che ha girato negli stessi territori flagellati dalle guerre. Dal maieutico e incisivo “Primavera in Kurdistan” al poetico e commovente “La strada dei Samouni” passando per il potente e drammatico “Piazza Tahrir”. Autentico cinema del reale, politico, coraggioso e coerente sul piano etico ed estetico. Se volete, poi, vedere un documentario sulle conseguenze della guerra sui più deboli, dall’approccio diametralmente opposto, onesto, che indaga e rappresenta con sofferenza e immenso rispetto, la vita dalla prospettiva di chi subisce gli effetti della guerra, e con la consapevolezza dei limiti anche etici connessi anche alla sua stessa realizzazione, cercate “Non è finita la pace, cioè la guerra” di Gianni Amelio. Lì uno sguardo ben più maturo, pulito e semplice, fa emergere con chiarezza, dalla riflessione su fatti intricati e controversi, complessi e traumatici, l’inutile assurdità della violenza. Lì non guardiamo bambini vittime della guerra, i bambini ci guardano e ci interrogano.
- MALIZIA di Salvatore Samperi, 1973
A volte i film invecchiano sviluppando strani effetti collaterali. “Malizia”, classico pilastro del Cinema erotico (era il 1973, anno de “Il Padrino” e “Ultimo tango a Parigi”) è col tempo diventato più intelligente e coraggioso nelle intenzioni. All’interno del genere della commedia leggera questo film è capace di rappresentare e sfidare alcuni tabù legati a famiglia, sessualità e costumi sociali . “Malizia” inizia con un funerale e finisce con un matrimonio, racconta di Ignazio La Brocca (un Turi Ferro in gran forma attoriale) che rimane vedovo e con 3 figli da crescere; l’intera famiglia rimarrà fatalmente irretita dalla domestica Angela (Laura Antonelli) una brava e giovane donna che si trova a gestire con difficoltà crescenti la propria sensualità e quella dei maschi della famiglia. Mentre il capofamiglia si appresta a sposare “la serva” sfidando le dicerie popolari ed il figlio grande cerca senza successo di concupirla, il sensibile e romantico Nino (dell’età apparente di 12/13 anni) sviluppa una fortissima e incontrollabile voluttà (che interessa anche la sorella di un compagno di scuola e Donna Ines, piacente e peccaminosa vedova cinquantenne): la sottopone ad una serie di giochi sensuali ed infine lei (il giorno prima del matrimonio) gli cede, iniziandolo a sua volta al sesso. Colonna sonora, dialoghi e situazioni esilaranti alleggeriscono una sceneggiatura indubbiamente scabrosa (il film era vietato ai minori di 18 anni) ma ispiratissima. Il dizionario a questo punto ci viene in aiuto con alcune ulteriori chiavi di lettura
malìzia s. f. [dal lat. malitia, der. di malus «malvagio»]. – 1. a. Tendenza, inclinazione a commettere il male consapevolmente: la m. del demonio; l’intenzione stessa, la volontà di fare il male, di recare danno
2 La conoscenza e l’esperienza di ciò che è male (come contrario di ingenuità): un bambino ancora senza m.; atteggiamento o espressione di furbesca allusione a ciò che è male; anche, compiaciuta tendenza a vedere il male anche dove non c’è: allusioni piene di m.; in partic., allusione erotica mascherata da apparente ingenuità.
- Gli invasati di Robert Wise, 1963
Questo film horror in bianconero ispirato al racconto “L’incubo di Hill house” di Shirley Jackson viene definito come il capolavoro di Robert Wise (poliedrico autore che realizzò ad Hollywood film dal 1944 al 2000, tra cui “West Side Story” e “Ultimatum alla terra” e “Tutti insieme appassionatamente”) e ci fa innanzitutto riflettere sulle definizioni di film di genere e film d’autore. Si tratta infatti di un’opera che per tutta la sua durata si misura con tale ambiguit;, in nessun momento, lo spettatore ha la certezza che quanto accade sia reale, oppure frutto dell’immaginazione dei protagonisti, inoltre l’evidente attrazione tra le 2 interpreti sembra abbia contribuito ad includere “The haunting” nella filmografia lgbt. Molto accurata è la sceneggiatura ed i dialoghi (magari un po’ ingenua l’interazione tra recitazione ed io narrante della fragile Eleanor) magistrale la progressione della tensione e in qualche modo prevedibile il destino dei 6 personaggi in riferimento al castello vivente che li ospita e poi li respinge. Anche lo stile delle riprese ed il sound design possiedono una qualità ben superiore alla media dei cosìddetti film horror degli anni ’60 e ’70. Nel 1999 è stato realizzato un remake che probabilmente non avremo bisogno di vedere. Altro film che ho scoperto casualmente è “La casa del terrore” (Seth Holt, 1961), più classico e meno pregevole e ma anche lui meritevole di essere visto.
- Bug. La paranoia è contagiosa di William Friedkin, 2006
Basato su un lavoro teatrale di Tracy Letts (autrice della sceneggiatura), è sicuramente un film minore di Friedkin (erede di Hitchcock con Brian De Palma, scrivono) regista di “Cruising” e “L’esorcista”), “The bug” è un film che cerca di essere disturbante ma risulta infine spiazzante suo malgrado. La storia presenta 3 personaggi principali all’interno di dinamiche psicologiche da thriller ma ad un certo punto il film prende la direzione dell’horror di serie b attraverso sviluppi veramente improbabili che mescolano (con effetti che sfiorano il ridicolo) la Sindrome della Guerra nel Golfo, disegni complottisti non del tutto assurdi, l’angoscia latente del personaggio femminile ( il cui figlio scomparve inspiegabilmente all’interno di un negozio di alimentari) e la cosìddetta parassitosi allucinatoria( in cui gli individui credono di essere infestati da parassiti o insetti). Lapidario e generoso il cenno sull’autorevole Internet Movie Database: “An unhinged war veteran holes up with a lonely woman in a spooky Oklahoma motel room. The line between reality and delusion is blurred as they discover a bug infestation”.
- Paradise Beach. Dentro l’incubo, di Jaumet Collet Serra, 2016
L’ennesimo film che ha protagonista lo squalo, a simboleggiare l’eterna lotta (tutta americana) tra il Bene ed il Male ha la pretesa di essere diverso da altri film dello stesso genere per via di una decisa estetica video. Pauroso ma rassicurante, il film mostra una rappresentazione “umana” del pescecane cattivo che si accanisce sul personaggio femminile in dinamiche veramente improbabili. Un tentativo di dare spessore ad una storia consiste nelle riprese di una telecamera sportiva GoPro che ha filmato gli attacchi dello squalo e che, trovata da un ragazzino, consente alla giovane donna di essere salvata. La cosa che fa più male non sono tuttavìa i terribili morsi del predatore mail finale in cui Nancy (con una vistosa cicatrice sulla coscia sinistra) con sorellina e padre (la madre, che si materializza come visione morì qualche tempo prima) torna a fare surf in una incantevole mare messicano.
- La marcia su Roma, di Dino Risi, 1962
Domenico (Gassman, un reduce della Prima Guerra mondiale che vive di espedienti) ed Umberto (Tognazzi, uomo di campagna attratto dalla promessa fascista delle terre ai contadini) sono i protagonisti di questo film in bianconero, a metà tra film storico e commedia che racconta in toni tragicomici la progressione fascista che culminerà nella marcia su Roma. Risi inserisce due figure importanti: il marchese latifondista che rammenta ai gerarchi l’appoggio dato ai “sovversivi” ed uno strampalato poeta ideologo al seguito della spedizione (che richiama la figura di Gabriele D’Annunzio). Un film attuale, dato che lo scorso 25 aprile avanzi del ventennio hanno in effetti ripetuto una marcia su Roma.
- POLYESTER di John Waters, 1981 E’ il 1981 e John Waters, riduttivamente definito come il re del cinema trash sferra un acidissimo attacco alla famiglia ed al sogno americano con l’ausilio dell’Odorama! (vedi sotto l’immagine del cartoncino con le 10 fragranze, distribuite per tutto il film). Fin dall’inizio lo spettatore viene trasportato in una dimensione narrativa intessuta di nonsense e puro disturbo, tuttavìa l’intera storia della povera, grassa e resilente Francine è gestita tra controllo e perdita di controllo, gli ingredienti cari a Waters ci sono tutti (Sesso, Religione e Morte) ma un inatteso happy ending, maturato dopo la lotta feroce tra il bene ed il male ed ogni tipo di distruzione, riporterà finalmente un pò di pace in casa. Una sana e gradevole lezione di Cinema da chi si divertiva senza pensare troppo al pubblico!
- Y TU MAMA’ TAMBIEN di A.Quaron, 2001
Come un impeccabile pruriginoso romanzo di formazione, “Y tu mamà tambien” racconta un viaggio in auto in un Messico inquieto, che lascia esplodere fatalmente una sequenza di segreti che tengono dapprima uniti Tenoch e Julio (2 ragazzi immaturi) e l’enigmatica, tormentata Luisa (poco più grande di loro). Il film è leggero e profondo al tempo stesso, intervallato da una voce narrante che aggiunge puntualmente approfondimenti storici, sociali e personali che ci permettono di osservare più da vicino i 3 personaggi, che si dirigono inesorabilmente verso un finale non lieto.
- LE MIE NOTTI SONO PIU’ BELLE DEI VOSTRI GIORNI di A.Zulawski, 1989
Sconclusionato quanto visionario, in questo film Z. sfrutta come idea narrativa l’attrazione fatale di Luca (un intellettuale pretenzioso dagli occhi azzurri ancora traumatizzato dall’avere assistito da bimbo all’annegamento dei genitori) per la veggente Blanche. Per l’intero film i due parlano in rima sull’orlo di una narrazione piena di nonsense e continue invenzioni, molto curata fino alla fine. La personalità di Luca , cui ad inizio film viene diagnosticato un tumore al cervello, mette a sicuramente a dura prova la pazienza dello spettatore (contemporaneo) secondo dinamiche tipicamente anni ’70.
- SESSOMATTO di Dino Risi, 1973
Film ad episodi incentrato su tematiche erotiche, esempio non eccelso del genere di pellicole che hanno consentito ai nostri genitori di condividere senza troppa vergogna nelle sale cinematografiche educate fantasie erotiche. In ogni storiella compaiono puntualmente Giancarlo Giannini (in gustose incredibili trasformazioni estetiche ed attoriali) e Laura Antonelli (al meglio della sua forma) negli schemi uomo-donna. Per quanto alcuni episodi siano effettivamente piuttosto prevedibili, “Sessomatto” è un valido contributo alla scoperta dei costumi e dei pruriti dei favolosi anni ’70, tra tradimenti, gelosìe, equivoci e colpi di scena riservandoci pure qui e là accenni e sfondi sociali affatto banali… Decisamente più interessante di tentativi sconclusionati come la trilogia “Poveri ma Belli” (1957).
- L’INGORGO – di Luigi Comencini, 1978
Autentico filmone diretto da Luigi Comencini, a dire il vero è un film atipico per Comencini, sembra più un film di Ferreri o Citti, la pellicola racconta di una lunghissima coda automobilistica sul Grande Raccordo Anulare, in cui i protagonisti mettono alla berlina i loro lati brutalmente più egoistici, ci saranno pestaggi, uno stupro, tentativi di corruzione e concessioni sessuali per ottenere un lavoro, i soli personaggi positivi sono quelli che avranno la peggio, nell’assoluta indifferenza di tutti: la scena dello stupro con i quattro testimoni che osservano come spettatori in un cinema è veramente impietosa. È un’amarissima e tratti surreale riflessione sull’Italia, ferma e incapace di muoversi, schiacciata da un’esistenza meramente materialistica che ignora il rispetto e la pietà, l’ammasso di auto demolite che fa da contorno all’ingorgo, sembra essere la giusta metafora di un’umanità priva di valori, misera e senza salvezza. Questo si che è un vero pugno allo stomaco, altro che “Favolacce”.
L’ingorgo agisce come elemento livellatore di ogni differenza sociale e morale e di ogni conflitto latente, che viene tuttosommato controllato rispetto alle proprie potenzialità. In questa crisi tutti, uomini e donne, sono diversi ma uguali ed ognuno esce da sé stesso in maniera diversa. Dentro e fuori le autovetture bloccate accade di tutto, ogni istinto (perlopiù peggiore) viene liberato in maniera più o meno lecita. Comencini (ispirandosi ad un racconto di Julio Cortazar, che però non viene accreditato) traccia un’opera universale che riesce incredibilmente a trattare ogni tema individuale e sociale: Lavoro, salute, amore, desiderio, rimpianto, tradimento, riscatto. Dal caos oppressivo di metallo e rumore il film diviene progressivamente silenzioso, astratto e metafisico. Nel finale, un elicottero impartisce con megafono istruzioni a tutte le macchine (difficile non pensare alle prime prove di controllo sociale in era Covid-19) che comunque restano immobili mentre cala lentamente la luce, segno chiaro che non vi sarà alcuna via di uscita.
Nelle microstorie de “L’ingorgo” c’è compassione, che tuttavia a volte viene punita: mi riferisco alla scena dello stupro da parte dei 3 ragazzotti borghesi in Land Rover (il riferimento al massacro del Circeo, avvenuto solo 3 anni prima sembra puntuale) ed alla tremenda vendetta, poi non portata a termine dal giovane che trasporta gli omogeneizzati (che verranno poi distribuiti a tutti) col suo furgone, al monologo della giovane madre che racconta come il bimbo di 6 anni che dorme nel sedile posteriore in realtà non si è mai svegliato perché affetto da un male incurabile, alla fiera ragazza napoletana incinta –che sogna di diventare cantante- che l’intera famiglia vorrebbe abortisse per lavare l’onta sociale (e che poi, ricevuti denaro e promesse discografiche da un potente afferma che infine potrebbe anche fare contento il papà).
No, non c’è speranza per nessuno e Comencini in questo pregevole trattato sociale si tiene sempre distante da ogni tentazione retorica. Il duro monito all’uomo è affidato alle parole del sacerdote, che impartisce l’estrema unzione al morto dentro l’ambulanza, in una delle scene madri di questo film disperatamente importante e profetico.
- COME SONO BUONI I BIANCHI di Marco Ferreri, 1988
“Come sono buoni i bianchi” di Marco Ferreri: in realtà ne ho apprezzato più l’idea di fondo e il doppio senso del titolo che il film stesso, il film ha non pochi difetti, soprattutto di sceneggiatura, ma anche la prova degli attori non è convincente, e poi secondo me si dà troppo spazio alla patetica storiella d’amore tra Placido e Maruschka Detmers; però non si può che provare ammirazione per la forte invettiva tirata addosso l’occidente colonialista e ipocritamente altruista (una sgangherata e umanamente discutibile “compagnia dell’anello” è protagonista di una spedizione umanitaria in Africa), contrapposta a un’Africa meno ingenua da come viene dipinta, bisognosa più delle velleità propagandate dal finto mondo occidentale (le pile della radio) che dei beni di prima necessità, e l’ammirazione è più decisa per la scena finale, che probabilmente va considerato il vero fiore all’occhiello del film, perché tuona come una vendetta divina. Non è certo il Ferreri che mette a ferro e fuoco de “L’ape regina” o “La donna scimmia”, però anche debole e sottotono riesce lo stesso a sganciare un paio di schiaffi ben assestati
- CENSORED VOICES di M.Loushi, 2015
1967, guerra dei 6 giorni. Egitto, Siria e Giordania ammassano truppe ai confini con Israele, che reagisce rapidamente respingendoli indietro e guadagnando territori. 10 giorni dopo la vittoria israeliana, un gruppo di soldati va nei kibbutz per raccogliere a caldo i ricordi e le opinioni dei soldati, ancora storditi dall’esperienza della guerra. Dobbiamo a questa necessità la nascita di questo notevole e controverso (il 70% dell’audio venne classificato come “censurato” dall’esercito) film di montaggio che rappresenta una bella lezione di cinema documentario ed anche di un uso libero e stimolante della parola e dell’ascolto. Un grosso registratore a bobine riproduce le voci proprio mentre osserviamo i primi piani degli ex soldati (tra i quali lo scrittore Amos Oz), ormai anziani, che ascoltano, mai impassibili, le parole caotiche che troveranno lentamente una struttura drammatica, fino ad esplodere nei dolorosi interrogativi espressi sul finale. Mentre la pressione della guerra si allontana vengono fuori tutte le contraddizioni in un fiume caotico e ricco di sfumature: delusione, orgoglio, paura, gioia, compassione, il razzismo verso gli arabi, cinismo e disfattismo… Poi tutte le immagini di repertorio, il potente aldilà delle parole liberate dal nastro delle bobine: filmati di propaganda in stile americano e riprese amatoriali in s-8, immagini degli scontri a fuoco, i cadaveri sull’asfalto e nella sabbia del deserto, capre e cani nelle strade deserte di Gaza, le retoriche telecronache americane della ABC, i vincitori che sfilano sui mezzi ed i vinti lungo i muri (dove saranno probabilmente fucilati), poi in marcia con bambini lungo strade polverose, gli interni distrutti delle case arabe, la riconquista di Gerusalemme con la gente in festa… A mano a mano che i diversi blocchi di registrazioni si accumulano, il rimosso sembra farsi più definito e lucido, lasciando trasparire tutto l’orrore indicibile e non raccontabile della guerra.
Verso il finale del racconto perfino il telecronista americano cambia registro ed accenna ai crimini di guerra dei vincitori e ad Israele “da molti considerato 51° stato americano”. Alcune immagini dei civili arabi controllati e maltrattati sono stranamente familiari, molto simili ad immagini odierne (che invece non abbiamo mai visto e non vedremo) del conflitto a bassa intensità tra Palestina e Israele. “Gli arabi stanno vivendo ciò che vivevamo noi nella Seconda Guerra Mondiale” dice ancora una voce registrata, poi, su uno dei primi piani degli anziani soldati israeliani ascoltiamo con chiarezza: “Fintanto che soggiogheremo altre persone non saremo liberi”.
- MODELS di Ulrich Seidl, 1998
Lo sguardo cinico (ma sempre onesto e compassionevole) di Ulrich Seidl si posa stavolta sul mondo delle modelle austriache con modalità simili ad altre sue indagini sociali, che verranno perfezionate esteticamente in seguito (viene in mente soprattutto “Import/Export” ma anche “Canicola”). Alcune immagini ricorrono ossessivamente tra le storie parallele che si intrecciano: le sigarette continuamente accese e fumate in ogni ambiente, le bottiglie di birra in bocca, lunghe telefonate problematiche, le relazioni sempre difficili con giovani uomini, sostanzialmente inadeguati, le conversazioni tese tra lei seduta sul water e lui in corridoio, la cocaina e lo stordimento della techno in discoteca, la cura del corpo, la bilancia, il cibo scadente consumato a letto, il condom ed i rapporti non protetti ed infine i set fotografici (dallo studio di posa alla piscina al vagone ferroviario abbandonato). La scena madre è probabilmente rappresentata dal ricatto sessuale neanche troppo sottile, di Baumann, grande ed anziano fotografo. Anche in “Models” è notevole la capacità del regista austriaco di trasportare ogni austera messa in scena, con i suoi tempi dilatati, in una dimensione assolutamente ordinaria che evidenzia con precisione l’essenza interlocutoria dei dialoghi. “Models” riesce a costruire il racconto universale della amicizia tra donne, della distanza insanabile tra uomo e donna e ci dà la possibilità di scoprire i mondi che languono dietro la superfici perfette dei corpi; le fragili ragazze di “Models” vivono minuto per minuto in maniera tenera e disillusa il loro stesso sfruttamento ed un disperato anelito ad una quasi felicità, sempre momentanea.
- PRIVILEGE di Peter Watkins, 1967
Questo piccolo gioiello misconosciuto riesce a raccontare la cultura giovanile in maniera più acida e allegorica di quanto non abbiano fatto tutti i film rock degli anni ’70 (da “Quadrophenia”, 1979 e “Tommy”, 1975 fino ad “Arancia Meccanica”, 1971). Coerente col suo stile narrativo che intreccia abilmente fiction e documentario, Peter Watkins in questo film si spinge oltre lo pseudo-documentario “The War Game” (1966) che simula in uno stile cinema veritè gli effetti di un possibile attacco nucleare a Londra. Va anche oltre “Culloden” (1964) che racconta l’omonima battaglia in cui l’esercito britannico soffocò nel sangue la rivolta scozzese degli Jacobiti (1745); anche in quel caso le scelte stilistiche di Watkins ed i loro effetti collaterali sul contratto fizionale misero a dura prova gli schemi della critica cinematografica, fu però scritto questo: Culloden looked like a documentary of an event that occurred long before the film camera was invented.
“Privilege” narra dell’ascesa e della caduta della popstar inglese Steve Shorter ma descrive in maniera tagliente la progettazione dell’uomo massa e la società dei consumi legata al divismo, gestendo con attenzione il contatto con lo spettatore con l’inserimento di interviste e dichiarazioni degli stessi personaggi della storia. Scopriamo pian piano che Steve Shorter è un brand, un involucro vuoto privo e privato di identità per meglio incarnare le crescenti esigenze ed aspettative del pubblico adorante, del suo staff commerciale e delle istituzioni, che ne utilizzano il mito in maniera scientifica, per controllare e manipolare i malumori giovanili.
Nella scena iniziale Steve Shorter è in piedi all’interno di un’automobile, viene osannato dalla folla con una tale intensità che arrivano alla nostra mente le immagini dei regimi totalitari. In un primo show Shorter canta la propria ribellione disperata all’interno di una gabbia metallica, represso da sorridenti agenti di polizia ma è nel corso del grande concerto allo stadio che Watkins mette in scena lo Spettacolo disturbante della popstar (ormai pentita, per poter dare un messaggio più edificante a ragazze e ragazzi) con il reverendo Tate che fa recitare “We Will Conform” a tutti gli spettatori, le persone in sedia a rotelle sistemate nei posti d’onore sotto il palco, enormi croci fiammeggianti e militari che indirizzano al palco i saluti romani. Il prodotto Shorter, sempre più esausto e svuotato sceglierà infine l’autodistruzione sua e di tutto il meccanismo perfetto, mettendo in scena durante un banchetto ufficiale la propria disubbidienza, atto finale della propria disperazione di essere umano.
Il tema di questo documentario è già stato anticipato in lavori precedenti (specialmente in “Im Keller”/In the Basements, che non venne distribuito in Italia) sul rapporto con gli animali domestici invece Seidl ha fatto un film che si è guadagnato l’ammirazione di Werner Herzog, “Animal Love”. Nella rappresentazione naturalistica di Seidl ecco stavolta protagonisti borghesi austriaci in Africa. E’ sempre molto complessa la relazione che Seidl intesse con i personaggi dei suoi “documentari” (che presuppongono una costruzione piuttosto teatrale e addirittura pittorica di spazi e persone) ma nel caso di “Safari” sembra più profonda che mai.
Anche stavolta il regista austriaco non sembra volere giudicare (lo farà comunque e con grande precisione il montaggio, come sempre) mentre prepara un ritratto feroce su natura ed esseri viventi: animali, uomini bianchi, uomini neri. Seidl rimane comunque sempre onesto con lo spettatore, anche quando decide di mostrare scene spiacevoli. “Safari” è un implicita dedica al Cinema e quindi alla Morte.
Alcune immagini ricorrenti costruiscono ossessivamente il film: piccoli gruppi di uomini e donne (accompagnati da personale indigeno) parlano sottovoce mentre osservano a distanza gli animali con i loro binocoli. Attraverso le inquadrature dell’operatore guardiamo loro (sempre da dietro o di profilo) che guardano l’animale che stanno per uccidere. Centrano sempre il bersaglio con un solo colpo preciso; dopo lo sparo, che resta sospeso nel silenzio della savana, il padre si complimenta ed abbraccia il figlio, lo stesso fa altrove il marito con la moglie, sembra che abbiano superato una prova importante. Mentre l’adrenalina evapora del tutto, toccano e accarezzano con affetto la zebra uccisa, sistemano neppure troppo pietosamente la sua testa per la più classica foto-ricordo (che ricorderà per loro quello che è successo) con il cacciatore fucile in mano dietro l’animale, e lo sguardo assente in camera dell’animale.
Ognuno di questi cacciatori e cacciatrici è ben difeso nelle proprie convinzioni. Alcuni accennano alla legittimità di una caccia regolamentata e controllata (opposta al lavoro quotidiano del mattatoio), del corso della natura, dell’aiuto finanziario che il safari porta alle nazioni in via di sviluppo. Sempre all’interno di eleganti salottini con sedie e trofei parlano con competenza di animali, calibri e fucili, quotazioni dei trofei impagliati e addirittura della funzione della morte nella società contemporanea.
Ogni scena della caccia è sterile e pateticamente prevedibile, si vince sempre come al luna park, considerando la distanza dalla quale guardano e sparano non è rimasto nulla del duello mitico uomo-animale. Ma in una delle scene madri del film accade qualcosa: la magnifica giraffa colpita a morte improvvisamente ha un sussulto e muove il collo, l’uomo non sa se sparare un secondo colpo, la moglie ha paura. L’animale finalmente muore, segue il rituale previsto: grottesche manifestazioni d’affetto sul corpo esanime e la foto ricordo. “Era una vera guerriera!” esclama chi ha sparato. La giraffa viene sistemata su un automezzo, disarticolata come un giocattolo rotto e quindi trasferita in una specie di garage dove verrà scuoiata, con una certa dovizia di dettagli che non è tuttavia gratuita. All’inizio del lavoro sporco i clienti austriaci sono presenti sullo sfondo, poi non li vedremo più.
Nell’altra scena madre vediamo l’anziano cacciatore (decisamente più grezzo degli altri) appisolato dentro il capanno di osservazione; più tardi berrà una birra in lattina e rutterà, infine, ritratto accanto alla moglie, affermerà che in Africa si sono sempre trovati bene, quanto sia squisito il filetto di antilope e che i neri sono esattamente come i bianchi, eccettuata la pelle nera.
Seidl decide di fare risaltare in maniera sottile il dietro le quinte del suo documentario con una sequenza di ritratti in posa in stile fotografico: sono i neri, che beneficiano del costoso hobby dell’uomo bianco. Li vediamo immobili, sempre con sguardi inespressivi, con lo sfondo di animali impagliati appesi al muro, a volte consumano voracemente la carne dell’animale ucciso, altre volte ancora siamo dentro le loro case e loro sono ancora immobili. Alcune immagini mi sono restate in testa: il manto della giraffa mentre viene lavato, la testa della giraffa sul pavimento che sembra un enorme giocattolo. La chiusura del film è riservata allo stentato discorso filosofico del venditore di trofei su natura, animali, uomo, ecologia; siamo ancora in un salotto, con consorte annessa.
Non capiamo cosa cercano e cosa credono di trovare in un safari questi individui, nonostante cerchino e siano nelle condizioni di spiegarlo. In alcuni di loro l’amore per gli animali, coltivato da bambini con gli album delle figurine, si è trasformato in un’esperienza triste e decadente (probabilmente meno emozionante di un videogioco in 3D) che cerca di farli sentire vivi e lascia noi attoniti.
- HARRY, HE’S HERE TO HELP – Dominik Moll, 1999
Con questo film Dominik Moll, inizia a mostrare un certo talento nel raccontare con la dovuta precisione psicologica la follia, che si propaga lentamente e legittimamente tra le persone, come un virus. La lezione sembrerebbe essere stata quella di Hitchcock e di Lynch.
Michel, un generoso e giovane genitore in viaggio con moglie e 3 bambine, si imbatte per caso in una stazione di servizio in Harry, ex compagno di classe del quale si ricorda a malapena. Non riuscirà più a toglierselo di dosso perché il premuroso Harry, che lo aveva mitizzato per via di alcuni racconti giovanili che cita a memoria, ha in mente per lui grandi piani tramite i quali potrà dare la svolta decisiva alla sua vita limitata ed insensata. Harry Inizia comprando loro una grande automobile nuova, poi uccide i genitori ed il fratello di lui e, in un abile crescendo cinematografico, gli propone di togliere di mezzo gli ultimi ostacoli ad una sua piena e definitiva realizzazione umana: la famiglia. Sull’orlo dell’abisso a Michel non resta che far fuori l’amico Harry (che muore al colmo dello stupore) con una coltellata nell’addome, occultandone poi il cadavere. I lucidi piani di Harry, riaccendono in Michel l’ispirazione per la scrittura, giusto quando lo spettatore iniziava a temere che potesse essersi manifestato un transfer tra i due. Nella sequenza finale Michel osserva fiero moglie e figlie addormentate nel lussuoso spazio della macchina nuova, regalata dal generoso Harry. Vietato ai minori di 15 anni. Chi guarda il film potrebbe domandarsi: “Sarebbe potuto capitare anche a me?”
- MAMMUTH – Benoit Delépine e Gustave Kervern, 2010
Il sessantenne Serge (G.Depardieu) va finalmente in pensione, ma per recuperare tutti i contributi che gli spettano deve fare un viaggio, prepara quindi la sua gloriosa Mammuth che giace in garage. Il viaggio in motocicletta è soltanto una scusa per ritrovare alcuni lavori improbabili fatti in passato, Serge è sempre protetto dal suo amor perdu (così nei titoli, è Isabelle Adjany) che tanti anni prima morì per un incidente in sella alla medesima moto, che gli appare accanto ogni tanto.
Bel lontano dalla retorica di decine di viaggi alla ricerca di sé stessi, il regista di questo piccolo anarchico gioiello tra riprese in stile Cinema Veritè e cinema sperimentale anni ‘70/80 ci regala incontri “alla fine del mondo” con amici, parenti e sconosciuti, dialoghi surrealisti e soluzioni narrative esilaranti. Pierre è solo apparentemente uno stupido o un perdente, è invece un uomo che sceglie di perdersi (prima di tornare a casa dalla moglie), prendendosi nel frattempo tutte le rivincite sociali che può. La visionarietà di questo film, che sembra prendere forma mentre lo si guarda, lascia spesso stupefatti, proiettando nella mente dello spettatore una sola grande domanda, che riguarda il lavoro e lo sfruttamento delle migliori energie psicofisiche dell’essere umano.
- UNA LUCERTOLA CON PELLE DI DONNA – Lucio Fulci, 1971
Film irrimediabilmente datato, gioca sulla figura ambigua della bella protagonista, eroina e carnefice, e un intreccio da detective fiction. Florinda Bolkan interpreta una donna che, a causa di allucinazioni da psicofarmaci, sogna un delitto che poi scopre essersi avverato. Gli indizi fanno pensare a una doppia personalità della protagonista, ma poi gli eventi del film sembrano cancellare questa pista. L’azione, in location molto ‘filmiche’, prende spesso il sopravvento nella scena, con qualche inseguimento che schiaccia l’occhio a Hitchcock e De
Palma, con chiari riferimenti anche ad Argento e Antonioni, ma chiaramente senza la lucidità e forza d’astrazione del ferrarese. Alcuni momenti di camera a mano sembrano anticipare Dogma, e le scene in salone, con i Bacon alle pareti eleganti e resi innocui come tagli di Fontana, indugiano spesso sul dipinto della maschera mortuaria di William Blake. Errori di montaggio piuttosto vistosi (la ragazza nuda uccisa in posa da vamp che chiude gli occhi al flash) possono far pensare tuttavia ad un approccio ironico e metafilmico.
Rettangolo nero: esempio 1
“A differenza di qualsiasi altra immagine visiva, una fotografia non è una riproduzione, un’imitazione o un’interpretazione del soggetto, ma una sua traccia (…) La percezione umana è tuttavia un processo selettivo molto più complesso di quello di una pellicola”. John Berger – “Sul guardare” (About Looking, 1980)
Rettangolo nero: esempio 2
- YOUNG ADAM – David McKenzie, 2003
La parte centrale del film inizia nel momento in cui Joe (Ewan Mc Gregor) si disfa della sua macchina per scrivere meccanica scagliandola in mare; poi immagini del corpo di una giovane donna in sottoveste recuperata e adagiata sul molo, la mano di Joe poggiata sulla pelle bagnata della schiena. “Young Adam” racconta la vita tormentata di Joe, che trova lavoro come marinaio in una chiatta che vaga lentamente per i canali inglesi. Ben presto intreccerà una relazione clandestina con Ella (Tilda Swinton) moglie di Les (Peter Mullan, anche lui ottimo attore scozzese) mentre pian piano affiorano sottoforma di flashbacks immagini della altrettanto tormentata storia d’amore con la giovane Cathy, che in seguito ad un’incidente finirà annegata nelle buie acque del porto. Il film in verità non riesce a ricostruire in maniera credibile la figura maledetta di Joe/Alexander Trocchi (“Il Libro di Caino” è un viaggio parecchio crudo attraverso droga e tossicodipendenza) ma ha il merito di mantenerci immersi in un’atmosfera sottoproletaria sottomessa e sconsolata, nella quale ogni personaggio non è interamente buono o cattivo nella sua ricerca della felicità (almeno temporanea): Il sesso è quasi sempre fedifrago e viene sempre consumato in maniera animalesca e senza eccessivi sensi di colpa.
Un innocente ritenuto responsabile della morte di Cathy verrà infine impiccato e Joe non riuscirà ad impedirlo. “Young Adam”, fiera produzione tutta scozzese, è insomma un film forse scolastico ma onesto ed ispirato, soprattutto per via delle notevoli qualità drammatiche dei 4 attori principali.
- DOGVILLE – Lars Von Trier, 2003
Col passare degli anni abbiamo fatto esperienza del Cinema di Lars Von Trier come di uno strumento (quasi sempre piuttosto raffinato) per dare corpo alle proprie inquietudini, alle proprie tensioni morali e forse al sadismo col quale interpella ogni volta lo spettatore.
“Dogville” è un raffinato trattato di sociologia applicato ad una minuscola cittadina americana e ad i suoi abitanti. Con questo film Von Trier torna ad accanirsi contro l’America (vedi l’atroce galleria fotografica che accompagna i titoli di coda) grande Democrazia e patria dei più bui istinti consumistici e razzisti (come dalle recentissime cronache) già tre anni prima la trama di “Dancer in the Dark” culminava con l’esecuzione della pena capitale.
La piccola comunità di Dogville è asfittica, povera, buia materialmente quanto moralmente e senza speranza; è rappresentata come un grande laboratorio/set teatrale in cui ogni spazio è semplicemente delimitato sul terreno e sempre più crudelmente trasparente. Il caso (il destino) conduce la fuggitiva Grace a Dogville e la sua esistenza nella cittadina è contemporaneamente un dono ed una prova per la comunità stessa che lungo i nove atti si comporta diligentemente come una singola entità. Grace è soprattutto il rimosso di mariti, mogli e genitori che poco alla volta intravedono nella giovane donna una occasione per mettere in atto (in una successione di pensieri, parole ed opere, magistralmente scandita dal forbito e volutamente ridondante testo recitato dalla voce narrante) la pratica ipocrita del bene e soprattutto del male, esercitando il ricatto in ogni sua forma: sospetto, razzismo, compassione, sfruttamento, cattiveria e sadismo. Grace accetta e paga ogni termine del ricatto (dal proprio lavoro quotidiano presso ogni famiglia al soddisfacimento sessuale di tutti gli uomini) per farsi accettare e proteggere dalla comunità ma in realtà ogni ingiustizia che digerisce, quasi come fosse metafisicamente cibo, verrà inaspettatamente riconvertita in vendetta, morte e distruzione. Memorabili il dialogo col bambino Giason su punizione e senso di colpa, quello con Chuck il rozzo agricoltore che lei è costretta ad aiutare nella coltivazione delle mele e quello con lo spietato e complesso padre (un notevole James Caan) che viene col suo piccolo esercito di gangsters a riprenderla per riportarla a casa. Il film appartiene al periodo post-Dogma, tuttavia è girato in uno stile realistico più vicino al video che al Cinema per meglio esplorare, ancora una volta e pessimisticamente, il dramma umano.
- AMORES PERROS – A.Inarritu, 2000
“Amores Perros” fu inevitabilmente paragonato a “Pulp Fiction” (uscito 6 anni prima) soprattutto per via degli intrecci incidentali di storie e della concezione non lineare del tempo, che al tempo era effettivamente una novità.
3 storie si intrecciano incidentalmente in una città dominata da caos e dalla violenza, resa magnificamente dall’effetto straordinariamente fisico di suoni ed immagini (consiglio di vederlo o rivederlo in versione lingua spagnola e sottotitoli). I protagonisti di “Amores perros” sono appunto i cani, cani impiegati in combattimenti clandestini (ma non troppo), cani amati (e spesso uniche certezze affettive) e relazioni sociali (familiari e non) complesse, quasi sempre disfunzionali, tirate pericolosamente fino alle loro estreme conseguenze, come sottili corde di acciaio.
Ognuno dei personaggi lotta per vivere o per sopravvivere: Inarritu (ed Arriaga, lo sceneggiatore) non indugiano in facili derive emotive, al contrario mostrano compassione per i personaggi pur mantenendo sempre sudore, carne, sangue al centro della visione . Il grande valore di questo film sta nel raccontare la disperazione che vede professionisti, proletari e sottoproletari, uniti nel desiderio di accedere finalmente ai loro rispettivi sogni, che alcuni di loro intravedranno soltanto.
- FAVOLACCE – Fratelli D’Innocenzo, 2020
“Favolacce” è il tentativo, parzialmente riuscito, di raccontare gli effetti delle fratture sociali contemporanee all’interno della famiglia. L’espediente narrativo, che viene portato avanti con non troppa convinzione è quello del diario di una bambina, che viene completato da un adulto/voce narrante. In “Favolacce” bambini e adolescenti subiscono fino alle estreme conseguenze il narcisismo, i peggiori istinti indotti e la sostanziale inadeguatezza dei genitori.
Il limite sta soprattutto nelle intenzioni, nella volontà di volere raccontare una storia cinica che attraverso uno sguardo sociale/sociologico piuttosto piatto ed esteticamente manierista ci viene restituito con un prodotto inevitabilmente morboso ed artificiale, nonostante la performance realistica e spesso molto intensa degli attori e la ricerca di momenti astratti. Di certo il dialetto romanesco crea ulteriori difficoltà. Con le dovute differenze c’è chi ha fatto questo tipo di Cinema, mostrando più compassione ed autenticità, da Pietro Germi ad Ulrich Seidl…
- BATTLE ROYALE – Kinji Fukasaku, 2000
Nella solita società distopica (il film venne però realizzato nel 2000, in tempi non sospetti)
Le autorità giapponesi, preoccupate per la vertiginosa crescita della criminalità giovanile, decidono di varare la Millennium Educational Reform Act, conosciuta anche come BR act. Si tratta dell’estrazione a sorte di un gruppo di studenti delle superiori che dovrà partecipare al Battle royale, un crudele gioco di sopravvivenza, nel quale i ragazzi avranno il compito di uccidersi a vicenda per difendere la propria incolumità al fine di essere eletti vincitori e poter tornare finalmente a casa.
Nonostante “Battle royale” sia costretto dalla sceneggiatura (dal romanzo di K.Takami, 1999) a dinamiche da videogioco, il film illustra in maniera interessante e non troppo semplicistica alcune scoperte della moderna psicologia di massa, come ad esempio l’esperimento della prigione di Stanford (1971). Il film risulta molto crudo e realistico ma concede qui e là qualche sprizzo di metafisica e di humour nero, affidati ad un trascinante Takeshi Kitano nei panni del Professore.
Il regista ha disegnato con una certa complessità i diversi modelli comportamentali degli alunni combattenti della 3B nel corso del massacro, riuscendo in qualche modo a bilanciare ritmo ed azione con la psicologia e rifuggendo da facili ambiguità, vi sono anche ricorrenti flashbacks della vita dei ragazzi. La grande maggioranza dei combattenti subisce inevitabilmente il cosiddetto effetto Lucifero ma sarà infine il bene a trionfare. Il Professor Kitano opera sul finale una scena enigmatica in cui pone volentieri fine alla sua vita familiare infelice. Il film ebbe un ottimo successo in Giappone (anche se fu oggetto di interrogazioni parlamentari e della condanna della Dieta Nazionale del Giappone) e venne censurato in vari paesi per l’eccessiva violenza. Il romanzo è stato adattato in una omonima serie manga ed al film seguirà “Battle Royale II: Requiem” firmato dal figlio del regista.
- DER BUSENFREUNDE – Ulrich Seidl, 1997
L’opera di Ulrich Seidl è caratterizzata da uno stile asciutto della messa in scena, in cui tende a far apparire il materiale girato come documentaristico. Il fulcro della sua ricerca è infatti il documentario con particolare attenzione alla cifra stilistica e il contenuto documentaristico dell’opera.
Ho deciso di utilizzare come premessa queste poche righe che ho trovato sulla pagina Wikipedia di Ulrich seidl.
“Der Busenfreunde” (l’amico del seno) film per la Televisione austriaca, il dvd è in lingua tedesca e non ha nemmeno l’opzione dei sottotitoli in inglese (soltanto in tedesco… come del resto alcuni film di Seidl pubblicati nella linea “Der Osterreichische Film – Der Standard” dedicati al cinema austriaco) e quindi la mia comprensione dell’opera è stata limitata, ma non so in effetti quanto.
Seidl drammatizza in forma documentaria le giornate del suo personaggio, un quarantenne professore di matematica che vive in casa con la madre anziana. Un’esistenza ordinaria? Difficile dare una risposta, l’uomo mette in scena comportamenti “normali” ed insieme disfunzionali, contraddistinti da una certa metodicità (accentuata dal montaggio stesso del film) e filmati perlopiù a camera fissa. L’individuo in questione è un raccoglitore seriale di quotidiani e riviste, che vediamo accumularsi in pile sempre più minacciose nelle stanze di casa, ogni mattina in classe attraverso la matematica concede ai suoi alunni curiose digressioni sulle donne (Senta Berger è protagonista di una surreale proiezione di diapositive in un’aula dedicata). Ogni tanto cerca svago e gli esterni prendono forma con potenza: lui nuota, poi seduto nudo su un grosso tronco, ruota solitario su una giostra per bambini…
Ma è nella routine quotidiana che il microcosmo del protagonista si fa complesso e scosceso: madre e figlio si incrociano appena negli interni soffocanti del quartiere popolare nel quale vivono, lei richiede delle attenzioni tenendo accesi tutti i fornelli della cucina, lasciando cadere di proposito a terra bicchieri di vetro ed alcune riviste impilate, mentre percorre il corridoio buio per rinchiudersi nella sua stanza. Verso la fine del film uno sconsolato monologo materno che il figlio subisce senza replicare, poi un dialogo teatralmente suddiviso in quadri. Sui titoli di cosa finalmente la musica: la marcia dei sette nani. Una vita come tante eppure unica.
In questa indagine sociologica (“messa in scena documentaria” priva di giudizio?) sui cittadini austriaci Seidl andrà molto oltre sia in “Hundstage/Canicola” che in “Im Keller”, soprattutto.
Ecco 2 commenti di utenti austriaci o tedeschi rintracciati su Amazon, che la rozza traduzione meccanica in lingua italiana ha reso assurdi:
Un lavoro sensazionale. Questi monologhi hanno più verità di coloro che
desiderano opere filosofie di molti altri. Un complimento alla città di Vienna, che porta a un tale genio! Sarebbe impossibile nella «città cosmopolita» di Berlino.
Non era il mio caso. Pensavo che il film si stesse abituando. Ma in qualche modo era troppo cinico e sarcastico per me.
- SIGNORE E SIGNORI, Pietro Germi, 1965
Con questa commedia divertente e claustrofobica, che si presenta sia come una storia di corna che come studio ben più complesso e problematico di famiglia e società italiana, Germi mette in scena con maestria un laboratorio dei peggiori istinti borghesi, tanto più che le vicende che si intrecciano hanno come protagonisti lo stesso gruppo di amici, stimati (e cattolici) professionisti di Treviso. In “Signore e Signori” si ride amaramente: ogni virtù occulta automaticamente un peccato, la tendenza di ognuno è quella di desiderare e concupire le mogli (ma anche i mariti) altrui in una coazione a ripetere ipocrita inquietante mentre i personaggi femminili che appartengono ad una classe inferiore (come Milena la barista, interpretata da Virna Lisi e la fanciulla del terzo episodio) appaiono i più fragili e verranno distrutti socialmente. Il tono della commedia è controllato ma corrosivo, alleggerito da un motivetto musicale ripetitivo, dal dialetto veneto e probabilmente anche dal bianconero delle immagini.
Nell’episodio finale, una minorenne di campagna, di cui gli “amici” approfittano sessualmente in cambio di scarpe, vestiti e beni materiali rischia di mandare tutti in tribunale; ecco però attivarsi occulti sistemi di autoconservazione che ci sono familiari: i cittadini “di specchiata onestà” che hanno nel frattempo provveduto a far tacere il quotidiano locale e influenzare il tribunale non finiranno sotto processo e verranno pienamente riabilitati (il rozzo contadino sarà accontentato con alcuni milioni di lire per essere subito dopo accusato di calunnia in tribunale). Nella scena finale si ritrovano tutti assieme ai tavoli del bar all’aperto; alcuni sguardi e ammiccamenti si incrociano, con la promessa che tutto continuerà, esattamente come prima, con l’obiettivo della conservazione della specie, nel bene e nel male. La battuta che resta in mente è quella del medico appena colto in flagrante adulterio la moglie con un amico (che si era finto impotente), esclama: “E che non si sappia in giro!” .
- L’ULTIMO TRENO DELLA NOTTE, Aldo Lado, 1975
Film italiano del 1975, si inserisce nel filone dei rape and revenge movies ed è considerato uno dei più crudi e violenti film mai realizzati in Italia; ebbe problemi con la censura in tutto il mondo, nel regno unito fu incluso nella lista dei “video nasty”e addirittura bandito. Morando Morandini sul suo dizionario assegna al film una stella, scrivendo: “Il film è un drammatico sovraccarico di efferatezze varie, senza alcun rispetto per la logica e la verosimiglianza…”.
Siamo d’accordo, “L’ultimo treno della notte” non verrà ricordato per le sue qualità cinematografiche, tuttavia ha il merito di riuscire a rievocare le atmosfere cupe e contraddittorie degli anni 70. Il regista sceglie di farlo spiando l’umanità ambigua riunita negli scompartimenti (nostalgici nazisti, uomini di chiesa e vari altri generi) poi attraverso una ingenua discussione tra Enrico Maria Salerno –il genitore vendicatore- ed i suoi commensali nel corso della cena di natale. Vero fulcro narrativo del film è l’enigmatica Macha Maril, che in seguito ad un rapporto sessuale consumato con Flavio Bucci nel gabinetto del treno inizia a liberare una carica sessuale sempre più nera e distruttiva, diventando un canale energetico tra la violenza dei due balordi ed i loro disgraziati bersagli, fino alla scena del giudizio finale, in cui guarda dritto in camera.
- NIENTE DA NASCONDERE, Michael Haneke, 2005
In “Niente da nascondere” Michael Haneke adotta solo in apparenza la formula del thriller psicologico, che viene continuamente solleticata e disattesa, fino a rarefarsi in una dimensione narrativa metafisica. Anche qui, come in “Benny’s Video” c’è una famiglia-società, anche qui etica ed estetica coincidono dolorosamente: la ripresa video si inserisce mimeticamente nella narrazione proponendo registrazioni e riproduzioni della cosiddetta “realtà” che costringono ancora una volta chi guarda il film a prenderne parte in qualche modo.
La casa e la vita di Georges, vengono guardate, filmate e restituite sotto forma di videocassette vhs da qualcuno che non si rivelerà e per motivi che rimangono insoluti, un espediente che porta il borghese Georges (personaggio televisivo di successo) a sviluppare un comportamento sufficientemente corretto ma sempre più inumano e disfatto, sia dentro che fuori casa, come se la famiglia stessa riproducesse al suo interno le disfunzioni sociali che intravvediamo sullo schermo televisivo (come accade anche in “Benny’s Video”).
In “niente da nascondere” il nemico non si vede mai proprio perché è interno, il presente ed il passato di fatto si contaminano, il senso di colpa di Georges coincide col senso di colpa della Francia nei confronti dell’Algeria, patria di uno dei personaggi che, consumato dai sospetti di Georges, si suicida davanti a lui.
Il contratto fizionale viene gestito da Haneke con una responsabilità estrema, l’economia narrativa sembra spietata (riprese a camera fissa, la dilatazione di momenti in cui non succede nulla di apparente, assenza di musiche) ma rivela invece compassione ed un grande rispetto per lo spettatore, che ha tempo e spazio per entrare dentro il film, per avvicinarsi ad ogni personaggio e non subire inutilmente un ennesimo Spettacolo.
- BENNY’S VIDEO, Michael Haneke, 1992
Siamo in campagna, vediamo un maiale ucciso da alcuni contadini sotto lo sguardo di alcuni cittadini, lo vediamo agonizzare mentre perde sangue e cadono fiocchi di neve. E’ un video girato da Benny, un qualsiasi adolescente austriaco che Haneke raffigura come mediamente problematico nella sua quotidianità e con l’unico linguaggio cinematografico necessario.
“Benny’s Video” è stato realizzato in un’era pre-Internet e trovo sia in grado soprattutto oggi di porre delle domande estremamente penetranti, sulla famiglia, sui giovani, sulla libertà, sulla normalità e sulla cosiddetta “Realtà”, con la benedizione non tanto di Orwell ma di Aldolf Huxley.
A Benny piace guardare film horror e soprattutto usare la telecamera/guardare le registrazioni sullo schermo tv nella sua stanza di giovane medioborghese (filmare e rivedere sono procedimenti disperatamente complementari). La sua telecamera amatoriale non sembra essere un mezzo tecnico del tutto neutro: ricordiamo bene che ha filmato l’uccisione del maiale. I genitori gli lasciano casa libera per il weekend, con il frigo ben fornito di cibo, Benny invita quindi una coetanea e dopo qualche ora trascorsa assieme tra noia ed imbarazzo le mostra il film del maiale ucciso. “Era solo un maiale” risponde alla ragazzina che gli chiede “Perché”.
Benny uccide la ragazzina con la stessa pistola rudimentale che abbiamo visto usare nel suo video, non sembra un incidente e sono necessarie altre 2 cartucce per farla morire. Lo fa senza un motivo (comportandosi in fondo come i 2 protagonisti di “Funny Games”) quindi nasconde il corpo dentro un armadio e lo vediamo controllare e riprodurre la sua abituale, ordinaria “normalità mangiando uno yogurth, uscendo di casa, vedendosi con un ‘amico. Un unico segno rappresenta finalmente il punto di non ritorno: la decisione di rasarsi i capelli a zero, che ha probabilmente la funzione di rivolgersi a mamma e papà, ai quali sempre attraverso una “normalità” esibita mostra sullo schermo che cosa è successo a casa. Lo spettatore a questo punto è in grado di osservare i riverberi di quello che è successo negli sguardi attoniti dei genitori, forse simili a chi ha mai visto uno snuff movie, dove tutto sembra vero. La famiglia a questo punto attua un percorso di rimozione per conservare la propria struttura: Madre e figlio vanno in Egitto per una breve vacanza, giusto il tempo perché il capofamiglia possa disfarsi del cadavere, ancora nascosto dentro l’armadio. “Perché?” gli chiede il padre. “Non lo so. Volevo sapere com’era” risponde Benny.
In “Benny’s Video” ogni decisione stilistica è implicitamente politica: audio fuoricampo, registrazioni video che si innestano nella narrazione, sequenze a camera fissa che lo spettatore si ritrova a “maturare” emotivamente, niente musiche ma audio di canali Tv generalisti (il conflitto nella ex-Jugoslavia, notizie degli attacchi a centri di accoglienza da parte di neonazisti tedeschi etc…) che a loro volta irrompono dentro la realtà lineare del film. La stessa sequenza finale, in cui Benny si presenta al commissariato di Polizia, viene spiata attraverso una telecamera di sorveglianza. Nulla è più autentico della rappresentazione, insomma. La morte registrata, riprodotta e controllata mediante la funzione rewind sarà sempre più normale, era appena il 1992.
Haneke è forse il regista che ha saputo mostrare con maggior programmatico rigore gli effetti del bombardamento d’immagini sulla psiche e sul comportamento umano.
In Benny’s video (1992), ambientato a Vienna, il protagonista è un adolescente di buona famiglia che svolge una vita apparentemente normale, simile a quella di molti suoi coetanei. In realtà i contatti che Benny stabilisce col mondo esterno sono sempre filtrati da un videoschermo. I genitori gli hanno regalato un’apparecchiatura che consente di riprendere quello che accade fuori dalla finestra della sua stanza e, quando non è impegnato in quest’attività voyeuristica, Benny trascorre gran parte della giornata davanti al televisore a fissare con sguardo inespressivo gli horror più cruenti. Quando invita nella sua cameretta una ragazzina conosciuta in un videonoleggio, non esita a mostrarle lo sconvolgente video che egli stesso ha girato, l’uccisione di un maiale con un colpo di pistola da parte di alcuni contadini. «Fico!», esclama lei. Da lì all’omicidio della ragazza il passo è breve. «In tv ho visto i trucchi che usano per gli effetti speciali. È solo ketchup e plastica!», osserva Benny.
Soffermiamo adesso l’attenzione sulla scena del delitto. Benny uccide la ragazzina, ma le cose sarebbero potute andare in maniera opposta: la vittima sembra talmente assuefatta alla violenza delle immagini che sarebbe potuta essere lei stessa a premere il grilletto. Dopo aver trascinato il corpo inerte per la stanza, Benny asciuga il sangue sul pavimento con un lenzuolo. Quando lo riappende al suo posto, dopo averlo lavato, esso non reca più alcuna traccia: è come uno schermo televisivo sul quale scorrono gli orrori più inenarrabili senza lasciare impronta.
Le immagini, nell’era della Comunicazione, scorrono in un flusso costante, amorfo e volatile, ma la loro eredità psichica ed emotiva è persistente ed esiziale.
- UP! – Russ Meyer, 1976
Credo sia il film più riuscito di Russ Meyer, dove lo scarto tra il caratteristico linguaggio dei corpi e le metafore visionarie lascia più spazio, la forte sensazione di non avere afferrato appieno l’essenza del racconto, apparentemente dominato da dinamiche di sesso, violenza e morte. In “Up!” le avventure di Margot Winchester, agente sotto copertura, si intrecciano con le figure enigmatiche di Schwartz e di sua figlia Alice Braun, qui catapultati dal Terzo Reich (non dimentichiamo che una delle presenze ossessive nei film di Meyer è non a caso Martin Bormann) mentre una delle Vixen di Russ Meyer presenta ripetutamente tutti i personaggi, quali elementi di una tragedia annunciata, allo scopo di rendere parossistico il ritmo del film. L’impianto narrativo risulta subito straniante e gioca in maniera astuta con le aspettative dello spettatore, senza soddisfarle interamente. Le donne, pur se fatalmente lussuriose ed infedeli, sono infine i personaggi positivi, a discapito di uomini meschini e violenti, prevedibili prodotti di una Società Yankee decisamente arretrata e conservatrice.
- WHERE TO INVADE NEXT – Michael Moore , 2015
Originale e apprezzabile l’idea di opporre all’ossessione americana per la guerra l’“invasione” pacifica di altri paesi, allo scopo di ricavarne idee e pratiche sociali e politiche da importare in patria per migliorare la qualità di vita degli americani.
Purtroppo per Moore la sua visione dei paesi che “invade” è sempre infantilmente stereotipata, univoca e faziosa. Mai problematica. La parte sull’Italia è imbarazzante. Il nostro paese viene dipinto come il paradiso degli imprenditori illuminati e dei lavoratori felici, che non conoscono lo stress perché godono tutti della tredicesima e di otto settimane di ferie pagate all’anno, che ci consentono di fare sesso, di mangiar bene e di vivere sereni. L’incursione italiana, a occhio e croce, sembra la peggiore del film, che ha comunque il merito di far conoscere allo spettatore aspetti di altri paesi che magari non sospettava. Tuttavia, se questa è la sua visione dell’Italia, è lecito dubitare che magari le mense scolastiche francesi non abbiano proprio tutte un menù da gourmet, che il celebratissimo sistema scolastico finlandese abbia comunque una sua darkside, che se l’Islanda si sia ripresa rapidamente dalla crisi del 2008 il merito non sia solo da attribuire all’ampia rappresentanza femminile all’interno delle istituzioni, che la condizione delle donne in Tunisia non sia proprio così rose e fiori dopo la nuova Costituzione del 2014, e così via. Un vero documentarista dovrebbe stimolare la coscienza critica dello spettatore, non imporre una tesi preconfezionata (anche se “giusta”), utilizzando il linguaggio cinematografico in maniera anche molto manipolatrice ed eticamente scorretta a scopo retorico, com’è consuetudine per Moore.
C’è anche del buono, tuttavia. L’“invasione” di Norimberga, ad esempio, ispira un appello agli americani affinché, come i tedeschi col nazismo, riconoscano i peccati originali che stanno alla base della “nascita di una nazione”, dal genocidio dei pellerossa, allo schiavismo, alla discriminazione razziale. Bello anche l’episodio berlinese, col ricordo autobiografico dell’abbattimento del muro, al quale lo stesso Moore prese parte e che da allora rappresenta l’evento spartiacque della sua vita, quello da cui continua a trarre, anche nelle congiunture storiche più disperate, l’ottimismo e la fiducia nel cambiamento.
- TEMPORADA DE PATOS – Fernando Eimbcke , 2004
- L’esordio di Eimbcke inaugura lo stile minimale dei lavori successivi: piani fissi, pochi personaggi, unità di luogo, sviluppo narrativo all’osso, apparente leggerezza. In questo primo film, girato in un bianco e nero opaco e scarsamente contrastato, ci troviamo in un casermone alla periferia di Città del Messico.La connotazione spaziale è ben definita già nell’incipit che omaggia un procedimento stilistico tipico di Ozu (ringraziato nei titoli di coda insieme a Jarmusch): alcune inquadrature fisse della durata di pochi secondi contestualizzano in maniera precisa e al tempo stesso allusiva la vicenda: squallidi caseggiati inquadrati di sottinsù sullo sfondo di un cielo grigio ferito dai cavi della luce, una bicicletta incatenata a un palo priva della ruota posteriore, un campetto da basket vandalizzato, le linee aeree di contatto della ferrovia, un grigio sottopassaggio, bambini che giocano sull’altalena in un’area verde sporca e a pochi metri dal traffico stradale, il condominio “Niños heroes”.È in un appartamento di questo edificio che avviene l’incontro tra quattro outsiders: due amichetti in età puberale contenti di godersi la domenica in assenza della madre di uno dei due tra sfide alla playstation, cocacola e pizza; l’invadente vicina, di poco maggiore, che si ostina a volersi servire del forno per preparare una torta e festeggiare il compleanno; un etologo sfigato, riciclatosi come fattorino di pizzeria, che occupa a oltranza l’appartamento, deciso a riscuotere la somma che gli spetta per la consegna e che gli viene negata.Quattro personaggi ben assortiti che s’incontrano in uno spazio chiuso per una serie di circostanze fortuite e che, tra alti e bassi, trovano comprensione reciproca nella condivisione delle proprie solitudini. Eimbcke, evitando accuratamente di scadere nel consolatorio, si destreggia con abilità sorprendente tra commedia, umorismo, malinconia, coming of age, dramma familiare ed esistenziale. Il perfetto amalgama tra i diversi registri fa levitare l’operina dall’aneddotico all’universale, suggerendo allo spettatore l’importanza della solidarietà tra marginali, un amaro senso di sconfitta e una voglia di fuga forse destinata a essere frustrata: la “stagione delle anatre” del titolo allude proprio alla migrazione di massa dei simpatici pennuti che va in porto grazie al ruolo occupato da ciascun esemplare nello schieramento di volo. Come Eduardo Galeano e Juan Diaz Bordenave, Eimbcke continua ad aver fiducia che, nonostante il modello di produzione neoliberista, “le anatre non saranno mai sconfitte”.
- SUICIDE CLUB – Sion Sono, 2001
Prima parte della trilogia di Sion Sono sull’alienazione, Suicide club è un thriller sociologico che esula dagli stilemi del genere, preferendo praticare l’autopsia dell’inconscio collettivo di una nazione, rivelando le ideologie, le ossessioni e le ambiguità più radicate e irrisolte dello spirito giapponese.
Il film ha un ritmo narrativo piuttosto tradizionale, sostanzialmente privo delle accelerazioni e delle concitazioni tipiche di certo cinema orientale, ma senza lesinare in kitsch, gore e succo di pomodoro, che nelle scene dei suicidi letteralmente esplode e dilaga nel campo visivo.
Memorabile la sequenza d’apertura, col suicidio collettivo di 54 ragazze liceali, “condannate a morte dalla nascita”, che si gettano allegramente sotto la metro tenendosi per mano. È il primo atto di un’epidemia di suicidi che sconvolge il paese. L’orrore si scoprirà eterodiretto dai componenti di una teenager-band, per mezzo del web e di pop songs orecchiabili e apparentemente innocue, il cui obiettivo è colpire al cuore l’irreggimentazione sociale, stigmatizzando il mito giapponese del collettivismo, qui rappresentato simbolicamente nella sua sclerotizzazione mortifera attraverso i ritrovamenti di bobine di rettangoli di pelle umana cuciti assieme.
Sono racconta la deriva delle nuove generazioni – ma il film si colloca ancora agli albori dell’era digitale –, spossessate della facoltà di scegliersi il futuro e spronate ad essere sempre più uguali-tra-gli-uguali. In una società che divora i propri figli, dove l’individuo viene sacrificato e stritolato tra l’ossessione della fama e quella del conformismo, la pulsione di morte sembra quasi l’unico atto libero, non predeterminato. Scegliere la morte è, in un certo senso, scegliere la vita. Nel finale il nichilista Sono sembra riservare tuttavia alla giovane protagonista, l’unica ad essere “connessa-con-se-stessa”, una possibilità nell’autodeterminazione del proprio destino.
- CLUB SANDWICH – Fernando Eimbke, 2013
Messico. Ambiente borghese. Madre single ancora in forma e figlio quindicenne trascorrono alcuni giorni di relax in un hotel con piscina, fuori stagione. Oltre a loro, unici ospiti della struttura, un insolito nucleo familiare composto da un padre molto anziano e bisognoso di cure, una madre di ghiaccio e una figlia adolescente, non proprio graziosa ma sicura di ciò che vuole: sedurre il coetaneo, dapprima paralizzato dalla timidezza, poi sempre più eccitato e disposto al “tradimento” della madre.
Non c’è altro nel film, occupato dagli ambigui rituali del complesso edipico che lega madre e figlio: il bagno e gli scherzi in piscina, la crema antisolare spalmata da lui sulla schiena di lei, i punti neri schiacciati da lei sulla schiena di lui, lo scambio dei pasti, la condivisione di confessioni intime e perfino del letto.
La regia minimale – la vicenda si svolge quasi per intero in unità di spazio e con un numero limitato di personaggi e situazioni – rende una traccia narrativa così essenziale paradigmatica della mutazione dei rapporti tra madri e figli all’epoca del tramonto della famiglia tradizionale. Eimbcke racconta con leggerezza e ironia ciò che gli psicanalisti più avveduti chiamano “plusmaterno”, quella deformazione invasiva e iper-protettiva del sentimento materno che, per compensare frustrazioni, insicurezze e fallimenti, finisce per fagocitare i propri figli, procrastinando all’infinito il momento della separazione e impedendo la crescita. Eimbcke però “tifa” per l’emancipazione e chiude beffardamente il film con il metaforico bacio d’addio alla madre appisolata e il ragazzotto che si chiude alle spalle la porta della camera d’hotel.
- MALANOCHE – Gus Van Sant, 1985
Il film d’esordio di Gus Van Van Sant fu senza dubbio un miracolo di economia e di potenza espressiva (elementi mai così interdipendenti) e raramente mi è capitato di assistere ad un film tanto “necessario”. “Mala Noche”, tratto dall’omonimo racconto biografico in forma di diario di Walt Curtis, mi ha dato la sensazione di scoprire e seguire trama e personaggi come scaturissero dalla lettura di un libro. Troupe ridotta a 3 persone, bianco/nero ed un’estetica visiva sperimentale, a tratti raffinatissimo e fisico Cinema Veritè, per una storia scabrosa e disperata di amori omosessuali ambientati nella zona vecchia di Portland (Oregon).
Nell’intervista contenuta nel dvd RaroVideo Van Sant accenna di avere inconsapevolmente ricalcato le 10 regole “Dogma” di Von Trier e compagni in un’idea che ricorda senz’altro Pasolini e Warhol ma anche le atmosfere estreme di “Queer” (bellissimo romanzo di William Burroughs). Lui stesso sottolinea come John Campbel (operatore solitamente impegnato in progetti documentaristici) fosse l’uomo giusto appunto perché abituato a catturare situazioni rapide in bilico tra luce, ombra, caos e ordine. Un racconto totale molto stimolante per lo sguardo dello spettatore, in cui camera-montaggio e sound design sembrano contaminarsi continuamente, del resto i 3 attori non professionisti/personaggi sono stati in grado di vivere in uno stato di continua improvvisazione. Ma non diremmo mai che tutto questo è basato su un rigoroso storyboard con 500 disegni…
- NOI E L’AMORE COMPORTAMENTO SESSUALE VARIANTE – Antonio D’Agostino, 1986
Charles Kilgore definì i “Mondo Movies” figli illegittimi del peep show e del Cinema d’antropologia. Questo film di Antonio D’Agostino trova una sua parentela con questi “documentari di finzione” che avevano più che altro bene interiorizzato le intuizioni e le applicazioni del Cinema di Propaganda.
In seguito i film Mondo, tenendo sicuramente conto del pubblico ormai saturo di narrazione (pseudo) documentaria, lasciarono posto alla fiction dei cosìddetti “Cannibal Movies”. Il tentativo di D’Agostino è pietoso dal punto di vista concettuale ma sociologicamente rilevante, il mondo delle Letteratura Scientifica precipita nel Cinema con esiti disturbanti. In questo film-saggio le anomalìe sessuali vengono illustrate con gustose e peccaminose scenette erotiche che riproducono il punto di vista dello spettatore, che sembra spiarle e sbirciarle egli stesso mentre un improbabile studioso, sempre concentrato ed impassibile, cita la scrittura di Von Masoch, De Sade e Krafft-Ebbing.
- LILITH – LA DEA DELL’AMORE – Robert Rossen, 1964
Ultimo film di Robert Rossen, regista e sceneggiatore (autore del più conosciuto “Lo spaccone” con Paul Newman). Il film è incentrato sui personaggi di Vincent (Warren Beatty) un ex militare alla ricerca di sé stesso che trova lavoro in un Istituto psichiatrico e soprattutto di Lilith (impersonata da Jean Seberg, che sarebbe morta suicida 12 anni dopo) giovane paziente che gli viene affidata. Già dall’inizio del film il mondo luccicante di Lilith, visionaria e ninfomane, ha l’effetto di contaminare sempre più sia il personaggio maschile che la trama stessa del film, proprio mentre lo guardiamo e la scelta del bianconero ha il potere di concentrare la potenza di questo transfer. E’ un film molto ispirato ed aperto, imprevedibile fino alla fine; interessante come le fantasie di Lilith, sconnesse e lucide al tempo stesso, sembrano implodere nella visione. Se la cosiddetta “realtà” è veramente uno stato mentale, questo film (al di là di alcuni passaggi narrativi improbabili) può dare un contributo importante a questa tesi, cinematograficamente molto intrigante.
- SCEMI DI GUERRA – LA FOLLIA NELLE TRINCEE – Enrico Verra, 2008 (Vivo Film/Provincia Autonoma di Trento)
La Grande Guerra ha sempre soddisfatto una grande dimensione immaginaria con film di finzione e documentari tv, molto spesso uniformi e poco interessanti, questo documentario della durata di 50 minuti è un contributo decisamente innovativo e necessario, non soltanto per il pensiero anti-militarista. “Scemi di guerra” è concentrato principalmente sul dramma degli effetti collaterali (lo shock da combattimento nasce con la guerra meccanizzata). Il doc tra l’altro sembra richiamare anche un rimosso contemporaneo: i soldati americani feriti in Afghanistan ed Iraq e poi abbandonati dal Governo in sacche invisibili di solitudine e disagio.
Lungo i filmati di repertorio e le interviste ad alcuni studiosi viene fuori un racconto toccante, preciso (mai oleografico) e lucidamente strutturato su aspetti mai o raramente sondati (dalla funzione delle lettere a famiglie e mogli come prospettiva di rifiuto dell’omologazione militare all’analisi sociologica di una generazione di contadini trasportati all’improvviso in un mondo meccanizzato). Diverse le tesi che si intrecciano tra loro con estrema cura, sempre affrontate in maniera anti accademica: Le dinamiche e gli effetti della perdita di sé, il disagio mentale come prospettiva di resistenza, l’assoluta inumanità ed inadeguatezza dell’Istituzione militare, Scienza Medicina nei confronti di giovani annientati, “curati” con l’elettroshock e poi “dimenticati relitti della Storia”. Notevole il tema musicale di Giuseppe Napoli (cui viene dedicato il documentario) contrappunto emotivo di tutta l’opera. Elenco i nomi dei capitoli: Soldato di Mauzan/Fiume di carta/Nelle trincee/Muro di silenzio/Fabbrica di morte/Guerra chimica/Scienza psichiatrica/Chiusi nei manicomi. Quel che rimane è un profondo segno di indignazione nei confronti di quell’idea oscena (ed inutilmente costosa da ogni punto di vista) chiamata Guerra. Sì, in quanto documentario funziona.
- FUOCOAMMARE – Salvatore Rosi, 2016
Quest’opera rappresenta la mutazione genetica del Cinema del reale che aspira ad arrivare al grande pubblico per diventare finalmente “Film” e “Cinema” (attraverso la benedizione televisiva). Probabilmente furono sintomatici i tentativi riformisti di Michael Moore all’interno della produzione cinematografica mainstream americana, che sembra in grado di digerire facilmente ogni apparente dissenso e di appropriarsene. Ogni singola inquadratura di Fuocammare ma anche ogni personaggio di questa storia-non storia -sempre esteticamente oppressiva- rivelano un desiderio troppo a lungo represso di “Cinema” e rivendicano una orgogliosa distanza dal famigerato (e deprimente per sua stessa definizione) genere “docu-fiction”. Se è vero che un film di finzione come “Salvatore Giuliano” rappresenti un valido contributo all’immaginario Mafia (potremmo citare anche “La vita è bella” rispetto a “Notte e nebbia” ed a tutto l’invisibile della Shoah, decisamente troppo impegnativo per lo spettatore comune) non è affatto esagerato affermare che la Sicilia ed i siciliani siano tuttora rappresentati in maniera più sincera e fedele dai film di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Per affrontare immagini e storie di migranti e sbarchi lontani da ogni ricatto morale consiglio piuttosto alcuni documentari “indipendenti” come ad esempio “U stissu sangu – Storie più Sud di Tunisi” di Francesco di Martino, realizzato in tempi non sospetti.
- CHIAMAMI COL TUO NOME – Luca Guadagnino, 2017
Questo film appartiene alla cosiddetta “Trilogia del desiderio” di Luca Guadagnino ed ha forse avuto il merito di mandare al Cinema qualcuna delle nostre madri o le nostre zie a vedere per la prima volta un film sui ricchioni (poverini). Perfino “I misteri di Brokeback Mountain” è stato un poco più utile alla causa omosessuale ed è bene ricordare che ad ogni polpettone corrispondono decine di pellicole lgbt misconosciute, a volte disperate ed importanti che nascono per ragioni e finalità ben diverse. “Chiamami col tuo nome”, già segnato dalla sceneggiatura di James Ivory, è un film delicato ed educato, ambientato in un sontuoso microcosmo altoborghese fiorentino; il film soddisfa principalmente le problematiche estetiche di Luca Guadagnino, qui magnificamente coniugate col desiderio di commuovere il pubblico eterosessuale, che difficilmente reggerebbe la visione di un film militante o impegnato. Il film riesce però (ne ho avuto prova) a raggirare parte del pubblico omosessuale. Per rifarsi il gusto suggerisco per esempio “Women in Revolt” (Paul Morissey, 1971) e “Mala Noche” (Gus Van Sant, 1985).
- L’UOMO CHE FUGGI’ DAL FUTURO – George Lucas, 1971
In un momento in cui appare chiaro come il controllo dei dati personali precede di poco il controllo dei corpi, una seconda visione di questo film di fantascienza è quanto mai illuminante. “L’uomo che fuggì dal futuro” (1971) addirittura ridicolizza l’immaginario dell’ultima produzione di “Fantascienza distopica”. George Lucas descrive con grande potenza e lucidità una società/fabbrica/città stato sotterranea estremamente claustrofobica, incentrata sul dominio produttivo ed intimo di uomini e donne, ognuno rasato e vestiti con divisa bianca. Tuttavia, ed è questo l’elemento veramente interessante del film, tale controllo capillare di corpi, produzione, sessualità e pensieri è veramente tale soltanto se interiorizzato da ogni componente di questa comunità (soprattutto attraverso l’uso di droghe istituzionali e la presenza amichevole di un’entità elettronica astratta, vagamente somigliante al Cristo).
Disfunzioni ed incidenti appaiono tuttavia come inevitabili effetti collaterali del grado di Controllo. Particolarmente inquietanti l’ambiguo personaggio interpretato da Donald Pleasance , il linguaggio dei poliziotti-automi, addetti alla repressione delle anomalie: (“Andrà tutto bene/Non ti faremo del male/Siamo qui per aiutarti/Non hai un altro posto dove andare”) ed i testi dei messaggi in filodiffusione che mescolano pubblicità di beni da acquistare ad inviti alla felicità.
Il nostro THX 1138 si ribella all’assunzione della droga di Stato, riscopre impulsi sessuali nei confronti della compagna LUH 3417 (che verrà presto distrutta), un normale e comprensibile malessere psico-fisico e lo spirito della rivolta. THX 1138 non ha particolari difficoltà ad allontanarsi verso la periferia e quindi evadere dal bianco accecante che pervade ogni immagine del film. Ad attenderlo, un mondo esterno non meglio identificato che si presenta con un grande globo arancione.
A questo punto sembra abbia un senso questa citazione di A.M. Johnson:
Il bambino si trovava di fronte al dilemma se credere al genitore o ai propri sensi. Se credeva ai propri sensi manteneva una salda presa sulla Realtà. Se credeva al genitore manteneva la relazione di cui aveva bisogno, ma distorceva la propria percezione della Realtà. (da “Studies in Schiziophrenia at the Mayo Clinic”, 1956).
Infine, “Il Dormiglione” (1974) con i poliziotti-automi vestiti in maniera praticamente uguale, sembra proprio una parodia di questo film, Woody Allen introduce inoltre una citazione dell’Orgone Accumulator di Wilhelm Reich, teorico delle prospettive politiche della Rivoluzione Sessuale.
- AGUIRRE – Werner Herzog, 1972
Rivedere oggi “Aguirre” conferma la grande potenza emotiva del film e la linea sottile che (non) separa la produzione “fiction” del regista da quella cinematografica.
La sceneggiatura evidenzia in maniera abbastanza chiara il carattere cinico e spregiudicato delle guerre spagnole di conquista (religiosa) in America Latina, c’è forse un’allusione al grande progetto americano di esportazione della democrazia. Le condizioni di ripresa del film (senza dubbio rischiose ed imprevedibili, come ammesso da Herzog stesso) hanno richiesto e necessariamente generato un linguaggio molto fisico, “documentaristico” ma sempre molto nitido ed impeccabile. Herzog rivela nell’intervista (extra contenuto nel dvd originale) di essere stato spesso in quegli anni contestato per i rischi cui aveva sottoposto gli attori/portatori indigeni nel corso delle riprese di questo film e in “Fitzcarraldo” (dove sarebbero morti numerosi indigeni). La dimensione metafisica di “Aguirre”, con lo scorrere delle scene, propone sempre più scene estatiche, e dense di riferimenti pittorici, nelle quali il nemico è sempre invisibile e Kinsky scivola gradualmente nella follìa. I rapporti problematici dell’attore con gli indigeni e col regista stesso vengono chiariti molto bene, e con affetto, in alcuni passaggi di “Kinsky: Il mio nemico più caro” .
- REQUIEM FOR A DREAM – Darren Aronofsky, 2000
Il Cinema di Aronofsky nasce da ossessioni estetiche/formali attraverso le quali il regista ibrida il linguaggio videoartistico con quello cinematografico, con invenzioni talvolta interessanti, altre volte sterili benchè “innovative”. Film successivi (come “Il Cigno nero”) lo hanno prevedibilmente consacrato come autore mainstream. Da premesse del genere Aronofsky ha sempre immaginato una sua complessità, con sceneggiature drammatiche e personaggi tormentati. “Requiem for a dream” non verrà ricordato come capolavoro ma riesce, con uno stile scolastico a rappresentare la discesa negli inferi di 4 personaggi. Retto dalla sceneggiatura (scritta assieme ad Hubert Selby jr, autore del libro da cui è tratto) e da un a buona resa drammaturgica degli attori, è in ogni caso il suo film migliore.
- “DONNE AMAZZONI SULLA LUNA” – Peter Horton, Hohn Landis, Robert K.Weiss, Joe Dante, Carl Gottlieb, 1988
Film ad episodi. Indubbiamente leggero e demenziale ma interessante nell’ideare un dispositivo nel quale diversi sketches potessero comunicare tra di loro, lasciando parte del compito allo spettatore, che di tanto in tanto non sa bene come reagire. I Monty Python furono certamente più motivati, questo film avrà rappresentato per John Landis ed amici una stanza dei giochi in riferimento alle rispettive carriere cinematografiche. Segue uno dei commenti più generosi che ho trovato su internet.
coordinato da John Landis ma diretto da altri quattro registi fra i quali Joe Dante, questo film, del 1986, aspira ad essere un’intelligente satira della televisione e delle sue aberrazioni, ma in realtà è soltanto un caos di disordinati spezzoni, che risultano spesso indisponenti. Infatti qualche rara battuta efficace e qualche trovatina non possono sostenere un lavoro inconsistente, che cade spesso nel cattivo gusto, e comprende sketch pesantemente volgari ed altri di demenziale scempiaggine.
- “LA SOUFRIERE” – Werner Herzog, 1977
“In attesa di una catastrofe inevitabile” è forse tra i primi documentari a chiarire l’approccio del maestro tedesco al Cinema e come in definitiva il suo pensiero visivo riveli una continuità proverbiale tra “documentario” e “finzione”. Autoritario quanto umano e delicato, Herzog mette sempre sul tavolo un pensiero complesso e fortemente problematico circa la relazione tra pianeta ed essere umano. Talvolta prende tutto il suo tempo, sembra divagare, crea dimensioni spazio-temporali che poco hanno a che fare con il normale tempo cinematografico e la cosiddetta “sospensione dell’incredulità” ma non possiamo negare la sua incredibile capacità di entrare in contatto con chi guarderà il film. In questo breve documentario Herzog lascia che le aspettative proprie e di chi attende la catastrofe si condensino in una dimensione instabile.
Dipinte in queste rive….
La prima immagine di un film di Werner Herzog, Kaspar Hauser, la vidi quasi due decenni or sono nella gloriosa saletta Achab: un campo di grano mosso dal vento con il commento sonoro del Canone di Pachelbel. Un incontro folgorante. Seguiva una didascalia dal Lenz di Büchner: Non sentite ovunque queste grida di terrore che normalmente chiamano silenzio? E poi la vicenda del buon selvaggio. Herzog mi si presentava come il regista degli ultimi, dei diversi, delle minoranze, dei folli sapienti e veggenti. Lucido e visionario.
Tre anni dopo Kaspar, Herzog inventa con La Soufrière una forma di narrazione cinematografica sospesa tra invenzione e realtà, percezione ed immaginazione. Allo spettatore il compito di ricucire gli strappi del visibile, squarciarne l’apparenza alla ricerca di una verità che nessun occhio umano o tecnologico potrà mai inquadrare. Viene messa in scena l’idea della catastrofe come fallimento del genere umano e della sua pretesa di dominio e controllo del pianeta. Fallisce anche il poco plausibile progetto di filmare la catastrofe. Gli attori del dramma: una natura potente, implacabile e beffarda (persino gli animali invadono gli spazi abbandonati dagli uomini), la paura degli uomini “civili”, parassiti della terra, presenze non necessarie, spettri come la città che abbandonano, la resilienza di chi è diverso, di chi sa attendere e accettare i disegni misteriosi e imperscrutabili della natura, un contadino filosofo, un savio ignorante, un nuovo Empedocle. Scopriamo con lui l’unicità e la ricchezza di ogni individuo, del suo idioma. Ad un certo punto intona una canzone, diventa uno sciamano. Egli solo non va incontro al fallimento: per lui la morte non è un trauma, ma un evento naturale. La natura resta là, sublime e terrificante. L’arte e la scienza non riusciranno mai a catturarne il mistero.
In In to the Inferno del 2016, documentario in cui visita alcuni tra i più attivi e pericolosi vulcani della terra insieme a uno scienziato conosciuto durante le riprese in Antartide di Incontri alla fine del mondo, Herzog introduce il racconto della sua esperienza di 40 anni prima nell’isola di Guadalupa con le seguenti riflessioni: “È un bene che esistano i vulcani. Ci fanno comprendere che il suolo su cui camminiamo non è stabile. Niente di ciò che facciamo è permanente, non c’è nessuna permanenza negli sforzi degli esseri umani, nessuna permanenza nell’arte e nella scienza.”